RICONCILIAZIONE FRA DIO E L'UOMO - VOLUME V
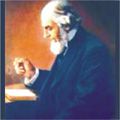 L'Autore Charles Taze Russell (Pittsburgh, 16 febbraio 1852 – Pampa, 31 ottobre 1916) è stato un predicatore statunitense, considerato il fondatore degli Studenti biblici, movimento che nel 1931 prese il nome di Testimoni di Geova e primo presidente della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
L'Autore Charles Taze Russell (Pittsburgh, 16 febbraio 1852 – Pampa, 31 ottobre 1916) è stato un predicatore statunitense, considerato il fondatore degli Studenti biblici, movimento che nel 1931 prese il nome di Testimoni di Geova e primo presidente della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
CHI ERA CHARLES TAZE RUSSELL? - Questa la sua storia!
"Riconciliazione fra Dio e L'uomo"
LA PREFAZIONE DELL'AUTORE
La prima edizione di questo volume fu pubblicata nel 1899: ed ora puó considerarsi diffusa ad un gran numero dei componenti del popolo di Dio, nei vari linguaggi del mondo civile.
Il capitolo, dall’intestazione “Santo - Innocente -Immacolato” [concernente le relazioni umane, che Gesù ebbe, dalla Sua nascita a Betlehem] suscitó - e suscita - un’attenzione speciale, per cui molti Cristiani hanno dichiarato ch’esso riflesse e riflette una grande luce, su molti e vari soggetti Scritturali e scientifici.
Con un sistema teologico che riconosce la sua imperfezione e chiede e aspetta l’insegnamento e l’illuminazione divina fino alla fine del percorso della Chiesa, sembra rimarchevole che questo volume scritto 19 anni fa, abbia bisogno solo di poche correzioni per essere in armonia con il recente pensiero degli Studenti Biblici per ciò che riguarda l’insegnamento della Parola Divina.
La principale peculiaritá del volume risiede nel capitolo concernente “il prezzo del riscatto”. Questo dottrina, dalla quale, apparentemente, ne derivano tutte le altre, connesse alla nostra salvezza é stata perduta di vista ed oscurata, sin dai tempi in cui gli Apostoli s’addormentarono, nel sonno della morte. E, sinora, permane in tale stato.
Gli studenti della Bibbia, invece, hanno considerato, e considerano, il “riscatto” quale una chiave, atta ad aprire le menti a discernere ed intendere il contenuto dell’intera Bibbia, oltre a reperire ció che costituisce la Veritá e riconoscere gli errori.
Le dichiarazioni della Bibbia, nei riguardi del “RISCATTO”, non sono state cambiate, in alcun modo. E noi riteniamo, fermamente che i soggetti, presentati da esse, sono e saranno infallibili. Ma, considerando la nostra fallibilitá, nell’esame delle Scritture, abbiamo sempre confidato - e confidiamo - d’ottenere il giusto intendimento, mediante la guida al giusto discernimento, dallo Spirito Santo, che ci fu promesso.
Ed ora, alla fine dell’esame del “Riscatto”, il suo contenuto brilla nei nostri occhi, per la commozione, trasfusa nei nostri cuori, dalla vivida luce dello Spirito Santo. Noi non contente stiamo contro la rivelazione progressiva del il Piano divino, anzi ne gioiamo. Non abbiamo motivi per chiedere scusa. Il riscatto si concentra davanti a noi in modo glorioso con gaggi nuovi di luce divina.
A questo punto, siamo in grado di riconoscere - ed, apprezzare - che Gesù, nostro Signore, rinunció al godimento della gloria celeste, per dedicarsi a compiere l’Opera del riscatto di Adamo e dei suoi discendenti. Rileviamo che il cambio della sua natura spirituale, in quella umana, fu necessario per abilitarlo a costituire il prezzo del riscatto, “dando sé stesso [uomo perfetto - dal greco ANTILUTRON - qual prezzo corrispondente], e ció, dal tempo della sua consacrazione, a trent’anni, in cui fu battezzato, nelle acque del Giordano, sino alla sua morte, sulla croce. Cosí, Egli perfezionó l’equivalenza del prezzo del Riscatto, per Adamo e la sua discendenza, aggiungendo, al sacrificio della sua vita, l’Opera d’Evangelizzazione, che espletó, sin quando chiuse il ciclo della Sua vita terrena, sulla croce, esclamando: “TUTTO É COMPIUTO!” Infatti, nulla di più aveva da compiere, oltre quello che gli era stato preordinato d’eseguire, per il compimento del Piano di Dio.
Gesù, nostro Signore, fu risuscitato dai morti, dal Padre celeste, in un Essere spirituale e, cioé, alla natura divina. Cosí [come ci precisa l’Apostolo, agli Atti 5: 31] “Lo esaltó, ponendolo alla Sua destra, nei luoghi altissimi, e costituendolo Principe e Salvatore, per dare ravvedimento ad Israele, e remissione dei peccati”.
Gesù non ha usato il prezzo del riscatto quando fu sulla terra, ne potè portare i suoi discepoli in relazione di comunione con il Padre. Così Egli dichiarò: Ascenderò al Padre mio e al Padre vostro, al mio Dio e al vostro Dio”. Poi dichiarò: “ Se io non vado lo Spirito Santo non verrà”. Giov. 20:17. Giov:16:7.
Circa i meravigliosi benefici, che Gesù concesse all’umanitá, mediante il Suo Riscatto, Egli disse ai suoi discepoli [apparendo loro su l’alto solaio, ove lo attendevano, secondo le istruzioni che aveva date loro, prima d’ascendere al cielo]: “Ecco, io manderó, su voi, quel che il Padre mio ha promesso [lo Spirito Santo]. Quanto a voi, rimanete in questa cittá, sin quando, dall’Alto sarete rivestiti di potenza [cioé dello Spirito] - Luca 24:49.
Per i meriti del Riscatto, Gesù ottenne dal Padre celeste, la Risurrezione e la Restauzione, per il mondo intero; la prima Risurrezione, per i Suoi fedeli seguaci, che “ebbero intendimento delle “cose profonde di Dio”e quindi, consacrandosi a Lui, “furono trasformati, mediante il rinnovamento della loro mente, onde conoscessero, per esperienza, qual fosse - ed è -la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontá” - Romani 8:17. Di conseguenza, i fedeli seguaci di Cristo usufruiranno, al pari del loro Capo, dell’onore, della gloria e dell’immortalitá, appartenendo alla Chiesa, della quale Egli sará lo Sposo. Si consideri, anche, che il Riscatto dell’umanitá, concederá a tutte le genti, la restaurazione alla vita perfetta [quale fu goduta dai nostri progenitori, prima del peccato] ed in eterno, sulla terra, anch’essa restaurata, allo stato originale. S’intende che per godere queste benedizioni, occorrerá osservare strettamente le leggi di Dio.
La ‘chiamata’ per la formazione della Chiesa, non costituí, né costituisce, ne aggiunge per arrotondare il prezzo del Riscatto, poiché il sacrificio di Gesù fu sufficiente. Essa fu progettata, affinché i seguaci del Maestro dimostrassero d’essere pervenuti ad acquisire lo stesso spirito e l’uguale disposizione, che ebbe il loro Signore e Maestro, nell’eseguire, ad ogni costo e, persino col sacrificio della vita, la Volontà del Padre celeste: onde essere accettati da Lui, quali membri del Regal Sacerdozio, del quale Gesù ne é il Sommo Sacerdote; nonché membri della Chiesa, della quale Cristo sará lo Sposo. Ai membri di questa classe, vien richiesto di servire Iddio, aderendo allo stesso Patto, al quale si sottopose Gesù. Infatti, Asaf [artista sovrano, pari ai grandi Profeti ] preannunció: “Dio dice, adunatemi i miei fedeli, che hanno fatto con me un Patto, mediante sacrificio.” Salmo 50: 5.
Or, allorquando i componenti di questa classe saranno pervenuti a completare il numero prestabilito, ed innalzati alla natura divina, come il loro Capo, saremo nel tempo in cui essi [Cristo e la Sua Chiesa] inizieranno ad esplicare il loro Potere, erogando la Giustizia divina, acquisita per i meriti di Gesù, onde giustificare l’intera umanitá.
Questo sacrificio - o prezzo di riscatto - sará presentato al Padre, quale corrispondente alla Giustizia divina, a favore dei peccatori [Adamo e la sua discendenza], alla fine di questa éra, ed al principio della Nuova, e costituirá la Giustificazione divina, ottenuta dal Redentore, per ogni creatura umana che va a Dio, tramite i meriti di Gesù, durante il Millennio, nel cui corso, Cristo e la Sua Chiesa erogheranno le benedizioni di vita, pace, e prosperitá che l’Eterno Iddio promise ad Abrahamo.
I membri della Chiesa in questo percorso di quasi 19 secoli non potevano essere sacrifici accette voli per Dio come fu per Gesù loro Redentore, perché solo Lui fu santo immacolato innocente – noi siamo imperfetti peccatori e Dio non può accettare dei sacrifici imperfetti con mancanze peccatrici.
Come si può fare per divenire sacrifici accette voli e permetterci di associarsi a Gesù sul piano spirituale? La cosa adeguata fu fatta - la giustizia divina accordò una attribuzione del merito di Gesù per tutti coloro che entreranno nel patto di sacrificio per il quale Gesù divenne l’avvocato o il garante. Questa attribuzione del Suo merito del sacrificio per la Chiesa, di Gesù, può assomigliare a una ipoteca o un debito, messa sul sacrificio di riscatto, che gli impedisce di applicare subito al mondo, fino a quando la sua applicazione per la Chiesa sarà terminata.
Il Patto, steso da Dio, con la Chiesa contempla che tutti i componenti d’essa, per divenire Nuove Creature in Cristo e coeredi Suoi, nelle Alte sfere spirituali, dovranno sacrificare la loro vita terrena. É su tale base che le Chiesa ha rinunciato - e rinuncia - ad ogni diritto ed agio, fruiti dall’umanitá, sacrificandoli, al pari di Gesù, divenuto il loro Sommo Sacerdote ed Avvocato, presso il Padre suo. In tal modo, i componenti della Chiesa acquisiscono ed acquisiranno il privilegio d’essere rigenerati dallo Spirito Santo, per condividere l’Opera sacrificale, giubilarne, al pari dell’apostolo Paolo, che a tal riguardo, scrisse in questi termini, ai Colossesi (1: 14): “Io mi rallegro, nelle mie sofferenze, per voi; e quel che manca alle sofferenze di Cristo, lo compio nella mia carne, a favore del corpo di Lui, che é la Chiesa’! Negli stessi termini, l’Apostolo si rivolge ai Romani (8: 16-17), dicendo loro: “Lo Spirito Santo attesta, assieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio e, se siamo figliuoli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pur soffriamo con Lui, affinché siamo, anche, glorificati con Lui. Or ricordiamoci tutti che sol quando questi spiriti rigenerati passeranno al di lá del Velo, i meriti di Cristo, depositati presso il Trono di Giustizia, avranno effetto per l’adempimento del Nuovo Patto. Lo stesso, Paolo, scrivendo agli Ebrei (8: 13), ci spiega: “. . . dicendo un nuovo Patto, EGLI ha dichiarato antico il primo, Ora, quel che diventa antico ed invecchia, é vicino a morire.”
Se sarà di nuovo da riscrivere questo volume, faremo via via delle modificazioni delle espressioni, in armonia con quello che già abbiamo presentato qui. Chiediamo ai nostri lettori di considerare questo. Le modifiche non sono di tale natura al fine di permettere che l’espressioni del libro siano sbagliate – solo che – non sono così complete e chiare come se il libro fosse stato scritto adesso.
Per alcuni commenti aggiornati sul nuovo patto, chiediamo ai nostri lettori di considerare la Prefazione dell’autore su “Studi delle Scritture volume, 6”.
Il vostro servitore nel Signore,
CHARLES T. RUSSELL
Brooklyn, N.York
1 ottobre 1916
INDICE
STUDIO I
LA REALTA’ E LA FILOSOFIA
STA ALLA BASE DELLA DOTTRINA CRISTIANA DAL PUNTO DI VISTA DELLA BIBBIA – TRE VEDUTE SU QUESTO SOGGETTO – “LA VEDUTA ORTODOSSA, LA VEDUTA ETERODOSSA”, LA VEDUTA DELLA BIBBIA CHE LI UNISCE E LI ARMONIZZA TUTTI E DUE – LA TEORIA DELL’ EVOLUZIONE ANTAGONISTA CON LA VERITA’ SU QUESTO SOGGETTO – LA RICONCILIAZIONE DELLA GIUSTIZIA DIVINA COMPIUTA – LA RICONCILIAZIONE DELLA CHIESA IN SVOLGIMENTO – LA RICONCILIAZIONE DEL MONDO IN FUTURO – I GRANDI RISULTATI FINALI, QUANDO IL REGNO FINIRA’ IL SUO RUOLO ...
STUDIO II
L’AUTORE DELLA RICONCILIAZIONE
L’ONNIPOTENTE GEOVA – IL SALVATORE DEI PECCATORI, ATTRAVERSO CRISTO – “DEGNO E’ L’AGNELLO” – “COLUI CHE ESISTE IN SE” – QUELLO CHE “IO SONO” – UNA TRADIZIONE FALZA – FONDATA SULL’ERRORE –
L’UNITA’ DEL PADRE E DEL FIGLIO MOSTRATA NELLE SCRITTURE – L’USANZA SCRITTURALE DELLA PAROLA GEOVA E DEL TITOLO IL SIGNORE – LA PAROLA DIO NE VECCHIO TESTAMENTO – NEL NUOVO TESTAMENTO – LA TESTIMONIANZA ARMONIOSA DELLA BIBBIA – CHI HA VISTO ME, HA VISTO IL PADRE – LUI NON LA CONSIDERO’UNA COSA SEMPLICE ESSERE AL LIVELLO DEL PADRE – PER NOI C’E’ UN UNICO DIO PADRE ED UN UNICO SIGNORE GESU’ CRISTO - …..
STUDIO III
IL MEDIATORE DELLA RICONCILIAZIONE L’UNICO GENERATO
CHI E’ LUI? – IL LOGOS, UN DIO – L’UNICO GENERATO DI GEOVA – LA TESTIMONIANZA DELLA BIBBIA – “COLUI CHE FU RICCO” – “PRIMA DI ABRAMO IO FUI” – “IL PRIMO E L’ULTIMO” – “IL LOGOS DIVENNE CARNE” – NON FU INCARNATO – LUI SI UMILIO’ – COLUI CHE FU RICCO, PER NOI DIVENNE POVERO – NON VI E’ NESSUNA IPOCRISIA IN QUESTA TESTIMONIANZA – LA CONDOTTA DEL NOSTRO SIGNORE NON FU FALZA – COLUI CHE FU SANTO INNOCENTE, SENZA MACCHIA E SEPARATO DAI PECCATORI. …
STUDIO IV
IL MEDIATORE DELLA RICONCILIAZIONE, COLUI CHE FU SENZA MACCHIA
SCRITTURE CHE APPARENTEMENTE SI CONTRADDICONO, SONO MESSE IN ARMONIA – LA DOTTRINA ROMANO-CATTOLICA DELLA GENERAZIONE DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA NON E’CONFERMATA – LA NASCITA DI GESU’ E’ DIVERSA DAI PECCATORI, ESSENZIALE PER IL PROGETTO DIVINO - ALTRIMENTI NON SAREBBE STATO POSSIBILE NESSUNA REDENZIONE – LE ULTIME CONCLUSIONI DELLA SCIENZA IN RELAZIONE ALL’UNIONE DELLA VITA CON IL PROTOPLASMA – IL LOGOS FU FATTO CARNE – NATO DALLA DONNA, MA SENZA MACCHIA - UNA MADRE IMPERFETTA LO FECE NASCERE SENZA MACCHIA – LO STESSO PRINCIPIO OPERA IN ALTRI ASPETTI DELPIANO DIVINO, SECONDO LE SCRITTURE.
STUDIO V
IL MEDIATORE DELLA RICONCILIAZIONE FU FATTO SIMILE AI SUOI FRATELLI.
CHI SONO I SUOI FRATELLI? – IN COSA STA LA SOMIGLIANZA – COME FU LUI TENTATO IN TUTTO COME NOI, MA LUI FU SENZA PECCATO – LE TENTAZIONI NEL DESERTO – L’ASSOMIGLIANZA DELLE SUE TENTAZIONI CON LE NOSTRE – ALCUNE TENTAZIONI POTRANNO IMBROGLIARE ANCHE GLI ELETTI – IN CHE SENSO FU FATTO PERFETTO IL NOSTRO SIGNORE ATTRAVERSO LE SOFFERENZE – ANCHE SE FU FIGLIO IMPARO’ AD UBBIDIRE – COME FU LUI FU FATTO SIMILE AI PECCATORI – SENZA MACCHIA – “LUI PRESE SU DI LUI TUTTE LE NOSTRE INFERMITA’ – COME EBBE MISERICORDIA
STUDIO VI
IL MEDIATORE DELLA RICONCILIAZIONE E IL FIGLIO E IL SIGNORE DI DAVIDE.
COME E’ LUI FIGLIO DI DAVIDE? - LA GENEALOGIA DI GIUSEPPE ATTRAVERSO SALOMONE – LA GENEALOGIA DI MARIA ATTRAVERSO NATAN – ABBASSA QUELLI INNALZATI E INNALZA QUELLI ABBASSATI –
DA DOVE PRENDE IL TITOLO DI CRISTO, IL SIGNORE DI DAVIDE – COME FU LUI LA RADICE IL RAMO DI DAVIDE – IL SIGNIFICATO DEL TITOLO PADRE DELL’ETERNITA’ – COME FU ASSICURATO E COME SARA’ APPLICATO – CHI SONO I FIGLI DI CRISTO - LA CHIESA “I SUOI FRATELLI” – I FIGLI DI DIO E IL PADRE DEL NOSTRO SIGNORE GESU’’ CRISTO
STUDIO VII
IL MEDIATORE DELLA RICONCILIAZIONE IL FIGLIO DELL’UOMO.
COSA NON SIGNIFICA QUESTO TITOLO – COSA SIGNIFICA - I SUOI ONORI SONO INCONTESTABILI, NON POSSONO ESSERE PRETESI DA NESSUNO – IL FIGLIO DELL’UOMO COSI’ COME E’ VISTO DAL MONDO – COME L’HA VISTO PILATO, ROUSSEAU, NAPOLEONE – IL SIGNIFICATO DELLA DICHIARAZIONE: “NON AVEVA BELLEZZA DA ATTIRARE GLI SGUARDI” – ERA DIVERSO DAGLI ALTRI – IL SUO ESSERE RIPIENO DI LUCE
STUDIO VIII
LA VIA DELLA RICONCILIAZIONE LO SPIRITO SANTO DI DIO
L’OPERA DELLO SPIRITO SANTO – ADESSO E’ NEL MILLENNIO – DIVERSI NOMI CHE HA LO SPIRITO SANTO – IN CONTRASTO CON LO SPIRITO DELL’ERRORE – COME LO SPIRITO SI ADEGUA A DIFFERENTI PERSONE – IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA SPIRITO – DIO E’ SPIRITO – LO SPIRITO SANTO NON C’ERA ANCORA – I DONI DELLO SPIRITO – LA POTENZA TRASFORMATRICE DELLO SPIRITO SANTO – SPIRITO CON MISURA E SENZA MISURA – LO SPIRITO DEL MONDO L’ANTICRISTO – LA LOTTA TRA QUESTO LO SPIRITO SANTO – LE LOTTE INTERNE ED ESTERNE DEI SANTI – LO SPIRITO CHE CI VUOLE CON GELOSIA - INSEGNATI DALLO SPIRITO – PARAKLETOS IL CONSOLATORE – LUI VI CONDURRA’ IN TUTTA LA VERITA’ – LA SORVEGLIANZA DELLO SPIRITO NON FU MINORE DA QUANDO CESSARONO I DONI MIRACOLOSI
STUDIO IX
IL BATTESIMO LA TESTIMONIANZA ED IL SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO DELLA RICONCILIAZIONE.
IL BATTESIMO DELLO SPIRITO – IN TRE PARTI – IL SIGNIFICATO DEL BATTESIMO – LE CHIAVI DEL REGNO DEI CIELI – ALTRO BATTESIMO DELLO SPIRITO PROMESSO SU OGNI CARNE – IL SUO SIGNIFICATO – LA PREGHIERA PER LO SPIRITO – LA TESTIMONIANZA DELLO SPIRITO – LA SUA IMPORTANZA – NESSUNA PACE CON DIO SENZA DI LUI – POCHI SANNO SE CE L’HANNO OPPURE NO – QUESTA E’ UNA COSA CHE DESIDERO CONOSCERE – COME RICONOSCERE LA TESTIMONIANZA DELLO SPIRITO – LE DIVERSITA’ DI AMMINISTRAZIONE – LA TESTIMONIANZA DELLO SPIRITO – SANTIFICATI ATTRAVERSO LO SPIRITO – PIENI DI SPIRITO – IL SIGILLO DELLO SPIRITO – LA PROMESSA CHE LO SIGILLA – PER IL GIORNO DELLA LIBERAZIONE – PIU’ ALTA REALIZZAZIONE DA RICERCARE – E MANTENERE.
STUDIO X
LO SPIRITO DI UNA MENTE SANA.
LO SPIRITO DI DIO DEL SUO POPOLO MANDA FUORI LO SPIRITO DELLA PAURA – L’UMANITA’ IN GENERE E’ MALATA SIA FISICAMENTE CHE MENTALMENTE – IL SENSO NEL QUALE LO SPIRITO SANTO E’ LO SPIRITO DI UNA MENTE SANA - LE OPERAZIONI CHE PORTANO A QUESTO RISULTATO – LE TESTIMONIANZE DELLO SPIRITO DI UNA MENTE SANA..
STUDIO XI
LO SPIRITO SANTO DELLA RICONCILIAZIONE.
L’ESAME DI ALCUNE SCRITTURE APPARENTEMENTE CONTRADDITTORIE – NON SPENGETE LO SPIRITO – NON RATTRISTATE LO SPIRITO DELLA VERITA’ – IL CONSOLATORE – PIENI DI SPIRITO SANTO – MENTIRE ALLO SPIRITO SANTO - TENTARE LO SPIRITO DEL SIGNORE – IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO SANTO - LO SPIRITO HA DETTO – LO SPIRITO SANTO E’ CONTENTO - FERMATI DALLO SPIRITO SANTO – LO SPIRITO SANTO TESTIMONIA – LO SPIRITO SANTO VI HA MESSO SUPERVISORI – LO SPIRITO SANTO COME INSEGNANTE – L’UNZIONE D I COLUI CHE E’ SANTO – LO SPIRITO SANTO MEDIA CON SOSPIRI – COME CRITICA LO SPIRITO IL MONDO – COME SI CONOSCE LO SPIRITO DI DIO A DIFFERENZA DELLO SPIRITO DELL’ANTICRISTO.
STUDIO XII
L’OGGETTO DELLA RICONCILIAZIONE : L’UOMO.
COSA E’ L’UOMO – LA RISPOSTA ORTODOSSA – LA RISPOSTA SCIENTIFICA – LA RISPOSTA DELLA BIBBIA – IL CORPO DELL’UOMO – LO SPIRITO DELL’UOMO – L’ANIMA UMANA – CONFUSIONE DALLE TRADUZIONI SBAGLIATE – MOLTIPLICAZIONE DELLE ANIME – COSA E’ LO SHEOL E L’ADES, DOVE VANNO TUTTE LE ANIME NELL’INTERVALLO TRA LA MORTE E LA RESURREZIONE – LE DICHIARAZIONI SCRITTURALI ANALIZZATE INDIVIDUALMENTE.
STUDIO XIII
LE SPERANZE DELLA VITA PERPETUA E L’IMMORTALITA’ ASSICURATE ATTRAVERSO LA RICONCILIAZIONE.
LE ASPETTATIVE O SPERANZE DELLA CREAZIONE CHE GEME - NON CI SONO TESTIMONIANZE – LE PROMESSE ED I RISULTATI DELLA RICONCILIAZIONE – UNA DISTINZIONE ED UNA DIFFERENZA – L’ANIMA UMANA E’ IMMORTALE, O A SOLO LA SPERANZA DI DIVENIRE IMMORTALE – GLI ANGELI SONO IMMORTALI – E’ SATANA IMMORTALE – LA VITA E’ IMMORTALITA’ PORTATA ALLA LUCE ATTRAVERSO IL VANGELO – LE PAROLE GREGHE TRADOTTE IMMORTALE E IMMORTALITA’ NELLE SCRITTURE – ATTRAVERSO CHE COSA SI DISTINGUE LA SPERANZA DELLA CHIESA DALLA SPERANZA DEL MONDO SALVATO.
STUDIO XIV
LA NECESSITA’ DELLA RICONCILIAZIONE – L’ELIMINAZIONE DELLA MORTE.
LA CONDANNA UN MALE ATTUALE NON FUTURA – DOVE E PERCHE’ VIENE LA CONDANNA PER TUTTI – QUANDO CESSERA’ L’IRA DI DIO CONTRO IL PECCATO – SALVATI ADESSO E IN FUTURO – LA RICONCILIAZIONE E’ NECESSARIA SECONDO IL PIANO DI DIO – L’UOMO, UN ESEMPIO PER GLI ANGELI E PER ATRE CREATURE FUTURE.
STUDIO XV
UN RISCATTO PER TUTTI UNICA BASE PER LA RICONCILIAZIONE.
LA RICONCILIAZIONE E’ IMPOSSIBILE SENZA UN RISCATTO – ASSICURATO MA NON IMPOSTO – ESSERE REDENTORE FU UN FAVORE – IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE PREZZO DI RISCATTO E REDENZIONE – CHE PREZZO DI RISCATTO FU PAGATO PER L’UOMO – LA GIUSTIFICAZIONE ATTRAVERSO LA FEDE E’ COSI’ ASSICURATA – VOI SIETE STATI COMPRATI CON UN PREZZO – ATTRAVERSO CHI – DA CHI – CON QUALE SCOPO – COME HA COOPERATO L’AMORE CON LA GIUSTIZIA – IL RISCATTO E’ MESSO PER TUTTI, NON SARA’ RIPRESO INDIETRO – I DIRITTI DEL PRIMO ADAMO COMPRATI DAL SECONDO ADAMO – IL RISCATTO NON SIGNIFICA PERDONO – LA MORTE DELL’UOMO NON E’ UN RISCATTO – UN RAGIONAMENTO FALZO DELLE TEORIE UNIVERSALI - LA GIUSTIZIA NON FU OBBLIGATA DALLA REDENZIONE – UNICO NOME – IL METODO DEL MEDIATORE SIMBOLEGGIATO ATTRAVERSO MOSE’ – LA REDENZIONE, SOSTITUZIONE – ERA POSSIBILE UN ALTRO PIANO
STUDIO XV
IL MINISTERO DELLA RICONCILIAZIONE.
QUESTO MINISTERO ERA AFFIDATO AL SACERDOZIO REALE – UNTI PER PREDICARE LA RICONCILIAZIONE – PERCHE’ NON E’ APPREZZATA LA NOTIZIA DI GIOIA – IL RISULTATI DI QUESTO MINISTERO – LA PERSECUZIONE E LA GLORIA – COME IN LEI SI PROVA LA FEDELTA’ – SOLO COLORO CHE SONO FEDELI POSSONO AVERE UNA PARTE NELL’OPERA DELLA RICONCILIAZIONE DEL FUTURO













