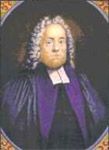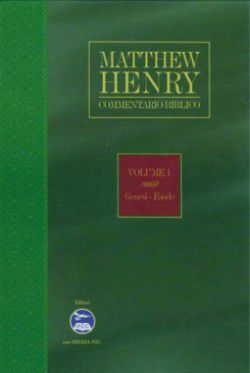GANDHI - Il risveglio degli umiliati
RETROCOPERTINA
È una delle rare figure che hanno saputo cambiare il mondo con la sola forza dello spirito. Ma com'è riuscito, quest'uomo fragile e dalla voce esitante, questo giovane avvocato fallito, a riunire milioni di uomini? Com'è avvenuto che le sue mille sconfitte si siano mutate in trionfo?
La vita di questo "santo laico" mostra che per non essere più umiliati bisogna prima smettere di umiliare, cambiare il proprio rapporto con l'altro. E Gandhi lo fece, dando l'esempio piuttosto che lezioni, insegnando il coraggio di cambiare se stessi prima di pretendere di trasformare l'altro.
Oggi è quanto mai attuale, perché mai come ora la violenza nel mondo è tanto minacciosa e multiforme. La sua prodigiosa contemporaneità emerge da molti fattori, tra cui l'idea di economia etica, la condanna della violenza, l'appello all'opinione pubblica, il ripudio della nozione di "potere".
Furono i voti di sincerità, castità, nonviolenza e povertà a far sì che la sua lotta non deragliasse mai? Gandhi scrisse che in lui la fede «divenne una forza vivente».
Tutti conoscono la sua storia, ma lui rimane comunque un emgma.
Sono rari i grandi uomini che non schiacciano, in un modo o nell' altro, quelli che hanno la sfortuna di essere i loro eredi. Più di ogni altro, per il livello di esigenza che imponeva a se stesso e che pretendeva dagli altri, Gandhi non poteva offrire ai suoi cari che una vita di sofferenze.
Innanzitutto ai suoi figli, che considerò sempre meno importanti di nipoti ed estranei, volentieri chiamati "figli", con gran danno dei quattro che gli aveva dato Kasturba, lei stessa vittima delle sue battaglie, che condivise senza comprenderle sempre.
Il primo martire di questa eredità funesta fu il primogenito, Harilal, il figlio meno desiderato; nato quando Gandhi aveva solo diciott'anni, per lui fu sempre soltanto una specie di fratellino ingombrante che non seppe allevare, né sostenere, consigliare o semplicemente tenere in considerazione. Per tutta la vita, questo figlio si sforzò, a modo suo, pateticamente, di farsi ascoltare dal padre, e la sua morte fu l'espressione massima delle sue tribolazioni: il 17 giugno 1948, solo pochi mesi dopo l'assassinio del padre, una coppia di passanti lo trovò ubriaco fradicio su un marciapiede di Bombay e lo portò in ospedale. Leggenda vuole che al medico che gli chiedeva il nome di suo padre Harilal abbia mormorato «Gandhi», ma che il dottore, spazientito, abbia risposto: «Ma no! Gandhi è il padre di tutti gli indiani! Come si chiama tuo padre?». Harilal trovò comunque la forza di farsi riconoscere; chiamarono due delle sue figlie, Rami Parikh e Manu Mashruwala, e lui morì il giorno dopo. Aveva sessant'anni.
Manilal, il secondogenito, rimasto da solo in Sudafrica a ventidue anni nel 1914, sposato con una ragazza scelta dal padre, diresse Phoenix fino alla sua morte, nel 1956, all'età di sessantaquattro anni; sua figlia, Gita, e il marito sono membri del Parlamento sudafricano e si occupano ancora di Phoenix; un altro dei figli di Manilal, Arun, vive negli Stati Uniti, a Memphis, dove gestisce un Gandhi Institute.
Ramdas, il terzo figlio, è stato a lungo padrone di una succursale dei frantoi Tata a Nagpur, la grande città vicino Sevagram dove si era trasferito lasciando il "villaggio costruttivo" , quando suo padre gli aveva proibito di mandare i figli a scuola; Ramdas muore a Bombay nel 1969 all'età di settantun anni.
Il figlio minore, Devdas, giornalista poi caporedattore dello «Hindustan Times», a Delhi, il più vicino al Mahatma, è morto d'infarto a Bombay nel 1957 all' età di cinquantasette anni; uno dei suoi figli, Ramchandra, è professore, e un altro, Rajmohan, è giornalista, uomo politico, e autore di un'importante biografia" di suo nonno.
Gli assassini, Nathuram Godse e Narayan Apte, furono impiccati il 15 novembre 1949; per evitare che fosse eretto un monumento sul luogo della loro cremazione, la polizia, riprendendo un' antica tradizione moghul, ne cancellò ogni traccia e vi seminò dell'erba, anche se si dice che qualcuno sia riuscito a spargere segretamente una parte delle loro ceneri in un fiume vicino". L'ideologo che li aveva ispirati, Savarkar, a cui nessun fatto poté essere imputato, fu prosciolto.
I quattro protagonisti della battaglia contro il Raj erano tutti avvocati: Gandhi, Nehru, Jinnah e Patel. Questi ultimi due, malati da molti anni, riuscirono a restare in vita abbastanza a lungo da vedere la fine della dominazione inglese.
Jinnah morì l'11 settembre 1948, per la congiunzione di una tubercolosi e un cancro ai polmoni, nel Pakistan che governava da tredici mesi.
Patel, molto malato, lasciò il governo nel giugno del 1948 per succedere a Lord Mountbatten come governatore generale dell'India fino all' entrata in vigore della Costituzione, il 26 gennaio 1950; troppo debole per diventare, come previsto, il primo presidente dell'Unione Indiana, lasciò quest'onore a un altro compagno di vecchia data di Gandhi, Rajendra Prasad, anch'egli avvocato, conosciuto ai tempi della sua prima battaglia in India, a Champaran. Patel morì il 15 dicembre 1950.
Dei quattro padri fondatori, l'unico sopravvissuto era Jawaharlal Nehru, che restò primo ministro per quasi vent'anni, elezione dopo elezione; salvò l'India dalla carestia nel 1956 con la "rivoluzione verde". Fece eleggere sua figlia Indira Gandhi come presidente del Partito del Congresso nel 1959 e morì ancora al potere per una crisi cardiaca, il 27 maggio 1964.
Almeno altri tre personaggi meritano che si dica qualche parola sul loro destino.
Il primo intoccabile ad aver ottenuto un dottorato, l'ex studente di Cambridge, Ambedkar, partecipò ai primi governi di Nehru in qualità di ministro della Giustizia e presidente del comitato incaricato della redazione della Costituzione; convinto che l'induismo non si sarebbe mai potuto liberare dell'intoccabilità, si convertì al buddhismo poche settimane prima di morire, il 14 ottobre 1956.
La dottoressa Sushila Nayar, compagna di sempre di Gandhi, divenne ministro della Sanità dei primi governi dell'Unione, restò in politica sotto Indira Gandhi, poi si ritirò nel 1969 per creare un Istituto Mahatma Gandhi per le Scienze Mediche. È morta alla fine del 2000.
Infine, Madeleine Slade, detta Mirabehn, visse fino al 1959 nell' dsram da lei fondato sull'Himalaya; poi lasciò l'India per stabilirsi a Vienna, come per tornare al suo primo amore: la musica, che era stata all' origine, tramite Romain Rolland, del suo incontro con Gandhi. La conclusione della sua epopea fu la conferenza che tenne nell'ottobre del 1969 , su invito di Lord Mountbatten, all' Albert Hall di Londra, in occasione del centenario della nascita di Mohandas, davanti a 7.000 persone tra cui il principe di Galles e il primo ministro. In seguito tornò a vivere nella capitale austriaca dove morì a novant' anni, il20 luglio 1982.
L'India, senza Gandhi
Il Mahatma avrebbe avuto buoni motivi per essere fiero dell'India di oggi: è rimasta un paese unito, con un musulmano come presidente [dal 2007 il paese è guidato, per la prima volta, da una donna; N.d.R.] e un sikh primo ministro; in essa convivono 900 milioni di hindu e 140 milioni di musulmani; l'età media di sopravvivenza aumenta incessantemente, il livello scientifico e intellettuale è ineguagliabile, la sua influenza nel mondo supera ampiamente quella dell'ex potenza occupante. Le idee di Gandhi continuano a vivere attraverso la Gandhi Peace Foundation; numerose associazioni (come il Sevak Sangh, i 'servitori del villaggio') proseguono l'opera di formazione che lui aveva lanciato nei centri rurali; una Commissione per la Promozione della kbad: e delle Industrie contadine, che lui desiderava, gestisce insieme allo Stato la produzione artigianale dei villaggi, in particolare della khiidl. Tre progetti che lui aveva in mente e che Vinoba Bhave portò avanti continuarono dopo di lui: la Sarvodaya Samaj ('Società del Servizio di Tutti'), creata nel 1948, il Bhudan (bhadiin, 'dono della terra'), creato nel 1951, e il Gramdan (griimdiin, 'dono del villaggio'). Essi permisero di trasformare un quarto dei villaggi del Bihar in comunità in cui un sesto della fortuna dei proprietari era destinato a beneficio dei meno abbienti.
Più in generale, Gandhi è divenuto un elemento essenziale dell'identità indiana; dal 1995, il governo di Delhi assegna un premio Mahatma Gandhi che ricompensa un' azione a favore della pace o della nonviolenza conforme ai suoi principi.
Il comitato Nobel si pentì tanto di non avergli assegnato il premio che, quando il Dalai Lama lo ricevette nel 1989, il presidente del comitato si sentì tenuto a dichiarare che era anche un «omaggio alla memoria del Mahatma Gandhi».
Gandhi sarebbe stato inoltre felice di notare l'influenza da lui esercitata su importanti leader del movimento di decolonizzazione e di lotta contro la discriminazione. Negli Stati Uniti, Martin Luther King lo citava spesso: «Il Cristo ha fornito lo spirito e la motivazione, e Gandhi ha fornito il metodo». Come anche Nelson Mandela: «Anche se il tempo ci separa, resta tra noi un legame, quello della comune esperienza della prigione, la nostra sfida lanciata a leggi ingiuste e il fatto che la violenza minacci le nostre aspirazioni alla pace e alla riconciliazione».
Altri ancora presero il testimone della sua opera, come quello studente cinese sconosciuto che, nel maggio 1989, affrontò, in piazza Tien An Men, a Pechino, una colonna di carri armati; o come Ibrahim Rugova nel Kosovo, e ancora oggi, Aung San Suu Kyi, in Birmania, che la giunta militare al potere a Rangoon non riesce a mettere a tacere.
La sua influenza è stata ulteriormente marcata dalla sua nomina, nel 1999, a "personaggio del secolo numero due", dopo Albert Einstein, e dall' approvazione all'unanimità, da parte dell' Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 15 giugno 2007, di una risoluzione che decretava il giorno della sua nascita "giornata internazionale della nonviolenza".
Ma tutto questo non gli sarebbe di sicuro bastato. Sarebbe stato probabilmente addolorato nel vedere che niente del suo progetto di società è stato davvero tenuto in considerazione dalla classe politica indiana; che non è stato fatto niente di serio per frenare l'esodo rurale, per alfabetizzare le campagne, per attirarvi le industrie, per migliorare le condizioni di vita e allontanare i cittadini dai prodotti alla moda provenienti dall'estero. Essendo morto senza eredi il suo discepolo Bhave, la khiidi e l'arcolaio sono ormai poco più che elementi di folklore, in una società animata da una sete di modernità occidentale. In questo universo, il Mahatma non è altro che un simbolo troppo esigente di cui non bisogna parlare troppo, quello di un progetto di società che più nessuno vuole, se mai qualcuno l'ha davvero voluto. Triste ironia, Gandhi oggi è più conosciuto dalle nuove generazioni indiane per due film bolly-woodiani del 2006, che per la sua opera e la sua azione reali: Lage Raho Munnabhai, che lo fa rivivere nel mondo contemporaneo e che ha fatto la fortuna di un neologismo oggi più popolare dello stesso Gandhi, gandhigiri - traducibile con 'gandhiano' -, e Gandbi, My Father, che ben racconta la vita di Harilal e i suoi problemi con il genitore.
Ma sarebbe ancora più afflitto nel sapere che nessuno dei problemi indiani che tentò di affrontare è stato risolto. Senza dubbio condividerebbe in parte il sentimento di Joseph Brodskij che osservava nel 1984: «Niente è cambiato in India dopo il ritiro degli inglesi, se non il colore della pelle dei suoi funzionari». Di sicuro, col triste sorriso degli ultimi anni della sua vita, stigmatizzerebbe la persistenza della povertà, l'ineguaglianza economica, la stagnazione della produttività agricola, lo sfruttamento del suolo, l'infanticidio delle figlie femmine, il matrimonio dei bambini, la reclusione delle vedove, la corruzione dell' amministrazione e del Partito del Congresso. Resterebbe indignato dall'aumento del consumo di alcolici, dalla corruzione dei costumi, dal degrado dell' ambiente, dall'immensità delle bidonville, dall'emarginazione dei dalit che si vedono rifiutare, ancora oggi, in quasi la metà dei villaggi, l'accesso a una fonte, a un tempio, a un ospedale o a un ristorante, e i cui figli, in oltre due terzi dei villaggi, non sono autorizzati a mangiare insieme agli altri nelle mense scolastiche.
Resterebbe sconvolto e costernato nel constatare che la violenza regna più che mai e dappertutto, specialmente nel Gujarat, sua terra natale, dove il governo regionale, retto dalla frangia più dura del Bharatiya J anata Party, ha lasciato infuriare, nel 2002, le peggiori insurrezioni dai tempi dell'indipendenza, nel corso delle quali più di 2.000 musulmani furono massacrati dagli hindu. Constaterebbe con desolazione che, nel mondo, la violenza prolifera, i massacri interetnici si moltiplicano, la povertà si aggrava; si rivolterebbe contro l'aumento del numero degli umiliati, degli sfruttati, del lavoro minorile, delle vittime dello sfruttamento sessuale. Si rattristerebbe nel vedere che pochi, nel mondo, credono ancora nella nonviolenza, e che lo stesso Nelson Mandela, malgrado la sua ammirazione per lui, non la utilizzò molto nella sua lotta contro l'apartheid. Prenderebbe atto del fatto che dopo di lui nessuno si è arrischiato a intraprendere una tale battaglia, se non dei terroristi pronti a fare uno sciopero della fame dopo aver lanciato le loro bombe. Sempre invano: Margaret Thatcher, ad esempio, contrariamente a Churchill, lasciò morire del loro digiuno in prigione dei militanti irlandesi condannati per atti di sangue. Gandhi osserverebbe che negli Stati Uniti nessuno osa riprendere la lotta di Martin Luther King e realizzerebbe che la maggior parte di quelli che subiscono ingiustizie e umiliazioni pensano ormai che l'accettazione della sofferenza non ha mai fatto piegare un dittatore. Resterebbe sconcertato nel sapere che il terrorismo guadagna terreno ovunque, in tutti gli Stati, su ogni continente, e che, nel suo stesso paese, Osama Bin Laden contende a Bhagat Singh il titolo di eroe degli umiliati.
Idee di un' estrema modernità
Malgrado o a causa di tutto ciò, la sua sfida al mondo rimane di una prodigiosa attualità. Prima di tutto perché la questione che lui pone resta il principale interrogativo di tutti i leader rivoluzionari: bisogna respingere tutto ciò che viene dal colonizzatore, compresa l'industrializzazione, o solo appropriarsene?
In secondo luogo perché ha visto prima di tutti gli altri l'importanza, per l'India come per il resto del mondo, del miglioramento della situazione delle campagne, del rifiuto delle bidonville, dello scambio equo tra produttori e distributori, del rispetto dell' ambiente. Inventando i rudimenti di quella che sarebbe divenuta l'economia etica, ha aperto una strada straordinaria, che riprenderanno dopo di lui tutti coloro che comprendono che la concentrazione dei mezzi di potere equivale solamente a un suicidio.
E più ancora perché ha compreso le conseguenze profonde dell'uso della violenza. Certo, non ha potuto impedire la divisione dell'India, ma almeno è riuscito, lì dove è intervenuto, a calmare quelli che erano pronti ad ammazzarsi tra loro, ma non a lasciarlo morire. È vero, non ha potuto arrestare la barbarie di chi, come Hitler, non dava peso né alla ragione né alla propria reputazione, ma ha posto dei principi che oggi acquistano una forza tutta nuova. Molto prima di chiunque altro, Gandhi ha visto che ottenere qualcosa con la violenza significa condannarsi a fame nuovamente uso per conservarlo e svilupparlo. Ha compreso, molto prima dei leader indipendentisti, che l'indipendenza non è un fine valido, se lo sfruttamento continua.
Infine perché ha realizzato, molto prima dei leader mediatici creati dalla nascita della televisione, che era essenziale rendere partecipe l'opinione pubblica. Ha potuto così trascinare decine di migliaia di persone con lui in Sudafrica, decine di milioni in India, facendo addirittura appello all' opinione pubblica inglese contro i politici di Londra. Oggi, con i nuovi mezzi di comunicazione, un dittatore non potrebbe nascondere a lungo al suo popolo le sue nefandezze e tutti i leader, anche i dittatori, sono bene o male sottoposti al controllo dell' opinione pubblica, nazionale o per lo meno internazionale. Dunque si potrebbe benissimo immaginare che un uomo o una donna, o anche migliaia di persone, potrebbero trascinare con sé miliardi di esseri umani in un satyiigraha planetario con slogan come «non paghiamo tasse per finanziare le armi!», «rifiutiamo di chiedere il permesso di soggiorno in un paese straniero!», «boicottiamo i prodotti che danneggiano l'ambiente!» oppure «smettetela di combattere!». Niente vieta di immaginare che un essere umano potrà un giorno più o meno lontano esercitare una sufficiente influenza e ascendente per pesare sui governi semplicemente mettendo a rischio la propria vita, o che potrà addirittura, magari, far tacere le armi intraprendendo uno sciopero della fame a oltranza in mezzo ai belligeranti.
Cambiare se stessi
L'impatto di qualcuno che dica così la verità sarebbe tanto più grande se costui avesse il coraggio di trasformare se stesso prima di pretendere di trasformare l'altro. E Gandhi sapeva, per esperienza, che ogni uomo, lui compreso, può diventare un bruto, un mostro, un assassino. Che ciascuno ha dentro di sé allo stesso tempo una bestialità smisurata e una formidabile capacità di amore. Dunque si riconosceva il diritto di predicare solo ciò che lui stesso riusciva a mettere in pratica. Mentre tutti gli altri leader rivoluzionari si accontentavano di elaborare dei piani per cambiare il mondo dalla loro scrivania, lui non voleva imporre un "uomo nuovo", ma voleva diventarlo lui stesso, e convincere poi con il suo sacrificio. Preferiva dare l'esempio piuttosto che lezioni.
Ecco, senza dubbio, l'aspetto più affascinante e importante di Gandhi: per cambiare il mondo, bisogna cambiare se stessi e avere come più alta ambizione, modesta e orgogliosa al tempo stesso, quella di dominare la propria violenza, i propri desideri, la propria sessualità, i propri sentimenti, per liberarsi di qualsiasi traccia di bestialità; poi, con l'aiuto delle pratiche ascetiche e di meditazione, ottenere un potere su di sé rinunciando al potere sulle cose; infine, e solamente infine, mettere questo potere al servizio di un ideale di un' estrema esigenza' facendone dono agli altri.
Oggi, mentre pulizie etniche e guerre di religione, mille e una divisioni, e barbarie di una portata spaventosa incombono ovunque, questa strategia della nonviolenza resta l'unica ad avere senso. Essa presuppone che qualcuno abbia il coraggio di venire a dire la verità, di viverla, di incarnarla. Ma, oggi, non si accetta più che qualcuno la gridi, tranne qualche volta i comici: come se solo la risata potesse renderla sopportabile.
La risata di Gandhi è senza dubbio ciò che chi ha incrociato la sua strada ricorda di più. Una risata di sfida, di tristezza e di compassione insieme; la risata di chi sa che il segreto della civiltà non è tanto amare il prossimo come se stessi quanto dirgli la verità, dopo aver avuto il coraggio di dirla a se stessi.
INDICE
Il Raj britannico p. 7 - Modh Vanik (1869-1888) p. 18 - Nascita a Porbandar, p. 19 - Matrimonio a Rajkot, p. 24 - La morte del padre, p. 33 - Prima ribellione: partenza per Londra, p. 34 Satavadhani (1888-1893) - p. 38 La scoperta della propria identità, p. 43 - «Vivere leggeri per arrivare a Dio», p. 47 - L'avvocato mancato, p. 51 - In mancanza di meglio, p. 53
Satyàgraba (1893-1914) 5;5 I coolie, p. 55 - L'umiliazione di Pietermaritzburg, p. 60 - Prime lotte, p. 62 - «Girmitiya Gandhi», p. 64 - «li primo chiodo sulla vostra bara», p. 66 - "Avvocato coolie", p. 70 - Nuove umiliazioni, p. 72 - Le ventisette domande, p. 74 - Scoprire Tolstoj, p. 75 - Il "quaderno verde", p. 76 - L'ombrello dell'inglese, p. 80 - L'avvocato prospera, p. 81 - Il giubileo della fame, p. 82 - Barellieri per gli inglesi, p. 84 - Abiti indiani, p. 87 - Kallenbach prende il posto di Rajchandra, p. 88 - Secondo ritorno in India: il primo Congresso, p. 90 - L'«lndian Opinion», p. 92 - Un'India immaginaria in Sudafrica, p. 95 - Prime riforme in India, p. 98 - Dai massacri all'astinenza, p. 101 - Il giuramento dell'11 settembre e il fallimento del primo satyàgraha, p. 104 - Prima ambasciata a Londra, p. 106 - Non registrarsi, p. 110 - Prima volta in prigione, p. 112 - Bruciare i documenti: il secondo satyiigraha, p. 114 - La prigione, ancora e ancora, p. 115 - Dolcezza contro brutalità, p. 118 - Contro 1"'Englishstan", p. 121 - La fattoria Tolstoj, p. 124 - Il terzo satyiigraba, p. 128 - La marcia delle donne, p. 130 - Il massacro di Durban, p. 131 - Vittoria con lo sciopero della fame, p. 134 - Fine dell'avventura sudafricana, p. 136 Hind swaraj (1914-1930) p. 141 - Dimenticare Kallenbach, p. 141- Uno sparviero affamato, p. 145- In prima linea, p. 148 - Primo lHram, p. 150 - Lo scandalo di Benares, p. 152 - Prima battaglia: l'indaco del Champaran, p. 155 - Liifram si trasferisce: Sabarmati, p. 159 - I due primi satydgraba in India: Kheda e Ahmedabad, p. 163 - Sergente addetto al reclutamento, p. 167 - Il primo soadesi, p. 170 - Il massacro di Amritsar, p. 172 - L"errore himalyano", p. 173 - Il silenzio, l'arcolaio, la dboti, p. Riunire i musulmani, p. 176 - Chiusura del caso Amritsar, p. 178- Un grande amore, p. 179 - La casta, prova «essenziale per una buona evoluzione dell'anima», p. 181 - Un satyàgraba per l'islam, p. 184 - "La legge della spada", p. 186 - L'imprudente promessa: l'indipendenza in un anno, p. 188 - L'anno del tutto o niente, p. 192 - Primo fallimento, p. 193 - Il massacro di Chauri Chaura, p. 194 - Sei anni di prigione, p. 196 - Leggere, scrivere, p. 199 - Liberazione nell'insuccesso, p. 201 - Il satydgraha di Vikom, p. 203 - In disparte, davanti alla violenza, p. 206 - Mirabehn e altre donne, p. 208 - Un anno nell'iifram, p. 212 - Nuovi viaggi, p. 218 - Prima rottura con Nehru, p. 220 - I "lavoratori silenziosi", p. 223 - Il «vangelo dei rivoluzionari», p. 226 - Scegliere una lotta, p. 227 - «Paralizzare il governo», p. 229 - Le undici richieste, p. 233 - Ultimi preparativi, p. 235 - La marcia del sale, p. 239 - Paralizzare il Raj, p. 243 - «Yerawada Palace», p. 248 Abimsà (1931-1939) - p. 251
Il Patto di Delhi, p. 252 - Difendere un terrorista ... , p. 255 - Una star a Londra, p. 257 - La capra da Mussolini, p. 259 - Ritorno a Yerawada, p. 262 - Lahin;zsii: un'etica indispensabile all'indipendenza, p. 264 - Difendere gli intoccabili loro malgrado, p. 265 - Rottura con il Congresso, p. 268 - Un «àiram nomade», p. 272 - La folle tournée, p. 274 - Primi attentati, p. 276 - L'India del polo e della caccia al cinghiale, p. 277 - Il «programma costruttivo», p. 279 - Sevagram: il villaggio sprimentale, p. 281 - «Mio figlio? Un miserabile», p. 283 - Il Mahatma fa i governi, p. 286 - Il passo falso con Jinnah, p. 289 - Il programma di Wardha, p. 291 - Ancora le donne, p. 292 - «Sushila resterà?», p. 294 - Due eiaculazioni involontarie ... , p. 296 - La nonviolenza contro Hitler, p. 299 - «Un mio amico ebreo» ... , p. 301 - Un nuovo satyiigraha?, p. 306 - Ritorno a Rajkot, «laboratorio prezioso», p. 308 - Lettera di un «amico sincero» a Hitler, p. 311 «Qui! India!» (1939-1945) - p. 314
L'indipendenza o la neutralità, p. 315 - La rottura con Jinnah, p. 317 - L'errore del Congresso, p. 320 - L'ostinazione pacifista, p. 323 - L"offerta d'agosto", p. 325 - Il "satyiigraha rappresentativo", p. 328 - «Lei non è il mostro ... », p. 330 - «Sepolto a Sevagram», p. 331 - Bose diventa Netaji, p. 333 - Tra la Germania e il Giappone, p. 335 - L'Inghilterra vacilla, p. 338 - La missione Cripps, p. 339 - «Quit India'», p. 345 - Non voglio che il Giappone vinca la guerra, p. 350 - Il palazzo-prigione, p. 354 - Netaji in Giappone, p. 355 - Traditore della patria, p. 357 - Il "governo provvisorio dell'India libera", p. 359 - «Una coppia fuori del comune», p. 361 - Ritorno a Imphal, - p. 363 - «Ma quel tizio è morto o no?», p. 364 - Faccia a faccia con l'assassino, p. 366 - La doppia integrità, p. 369 - Disfatta di Netaji, p. 370 - La pace, e poi?, p. 372 «He Rdm!» (1945-1948) 375
Le due utopie, p. 375 - «Come incanalare l'odio?», p. 379 - Scegliere Nehru, p. 381 - «L'odio è nell'aria», p. 383 - «Le fauci della morte», p. 385 - La grande carneficina di Calcutta, p. 386 - Ben oltre l'India ... , p. 389 - «I più bei momenti della mia vita»: il Noakhali, p. 391 - «La quantità di polvere ... », p. 392 - Violenza e sessualità, p. 395 - Ishwar e Allah sono i tuoi due nomi, p. 398 - «Il cammino della verità è lastricato di scheletri», p. 400 - L'offerta del 25 febbraio, p. 402 - Nel Bihar per proteggere i musulmani, p. 403 - «Sul mio cadavere», p. 405 - «Vivisezione dell'India», p. 406 - L'accordo del 2 giugno, p. 409 - Fine della paramountcy, p. 411 - Dimenticare Gandhi, p. 412 - Il miracolo di Calcutta, p. 413 - «La vita e la libertà», p. 414 - «Se Delhi affonda, siamo perduti», p. 415 - Il digiuno di Calcutta, p. 417 - Birla House, p. 420 - La scelta del Kashmir, p. 422 - «Il cuore pesante», p. 424 - La «mostruosa vivisezione», p. 426 - «L'unico sano di mente», p. 427 - «Lasciate morire Gandhi! Dateci un tetto!», p. 430 - Il Patto di Pace, p. 432 - Primo attentato, p. 433 - La promessa di Merhauli, p. 435 - L'assassinio, p. 438
Epilogo
L'India, senza Gandhi, p. 447 - Idee di un'estrema modernità, p. 450 - Cambiare se stessi, p. 452
Ringraziamenti 453
Bibliografia 455
Indice analitico 467