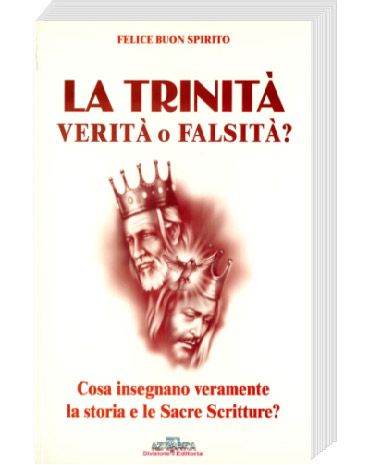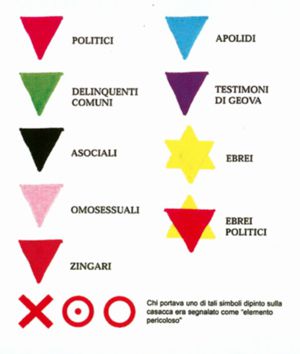LA CRONOLOGIA PERSIANA E LA DURATA DELL'ESILIO BABILONESE DEGLI EBREI: 50 o 70 anni?
RETROCOPERTINA
Quanto durò l’esilio babilonese del popolo ebraico: 50 anni o 70 anni?
Il diario astronomico VAT 4956 indica che il 37° anno di Nabucodonosor fu il 568 a.E.V. e la tavola Strm Kambys indica il 7° anno di Cambise come corrispondente al 523 a.E.V. Questo però lascerebbe solamente circa 50 anni per l’esilio in Babilonia del popolo ebraico, laddove la Bibbia dice, con certezza, che Gerusalemme restò una distesa desolata per 70 anni. Una o due delle fonti, quindi, deve essere necessariamente errata. Ma quale? Lo scopo della presente opera è di gettare nuova luce sull’argomento.
Saranno evidenziati i seguenti soggetti:
• La base per una cronologia relativa e per una assoluta;
• Come si possa stabilire la veridicità di una cronologia assoluta;
• I differenti resoconti cronologici nei tempi antichi;
• Perché non ci si può fidare a priori della cronologia delle tavolette di Saros;
• Come gli errori nelle fondamentali tavolette astronomiche inficiano l’intera cronologia
del mondo antico.
Viene presentato un nuovo schema cronologico dei regnanti di Persia
• Si calcola che ci sia un anno extra per Bardiya fra Cambise e Dario I;
• Ci fu una coreggenza fra Dario I e Serse, durata 11 anni;
• Il regno di Artaserse I deve essere spostato indietro di dieci anni; infatti, regnò 51 anni e
non 41;
• Si deve calcolare un anno extra fra i regni di Artaserse I e Dario II
INTRODUZIONE
Ho iniziato i miei studi sulla cronologia Neo Babilonese nel 1984, e ho continuato per alcuni anni a studiare le fonti e a raccogliere informazioni. Dopo un breve intervallo, ho preparato una piccola tesi sull’argomento, come parte del mio Mag. Art. Degree,1 a completamento della trattazione sul sistema verbale Ebraico. Negli ultimi sette anni, durante il semestre, nelle giornate del venerdì, un gruppo di insegnanti si radunava all’Università di Oslo per leggere testi Sumerici e Accadici. Per mezzo di queste riunioni, il mio interesse nei confronti dei documenti cuneiformi si è mantenuto vivo, e lo studio delle questioni cronologiche è continuato.
Quando ho iniziato la stesura del manoscritto di questo libro, la mia speranza era quella di essere in grado di presentare uno studio esauriente sulla Cronologia Assira, Babilonese, Persiana ed Egiziana, in rapporto con la cronologia Biblica. Man mano che il lavoro procedeva, mi sono reso conto che scrivere un libro su questo argomento, che analizzasse in profondità le questioni, richiedeva molto più lavoro di quello che avessi previsto.
Questo perché ci sono contraddizioni nei riguardi delle fonti, ed è importante esaminare se le discordanze riguardano le tavolette cuneiformi stesse, o se il problema è dovuto ad errori di lettura e stampa dei libri e periodici nei quali i dati sono stati pubblicati. L’analisi di importanti problemi di questo tipo, richiede molto lavoro. Un’altra ragione sta nella moltitudine dei dati cuneiformi che sono stati pubblicati, dati che provengono da diecimila tavolette. Un’altra ragione sta nel lento ritmo nella traduzione ed elaborazione del materiale cuneiforme riguardante la cronologia.
Tra il 1893 e il 1900 due grandi studiosi di quel tempo, T. G. Pinches e J. N. Strassmaier trascrissero un gran numero di testi astronomici, molto importanti per la realizzazione di una cronologia assoluta.2 Nei successivi 50 anni, solamente pochi studiosi hanno avuto accesso a questo materiale, e queste eccellenti tavolette ed i loro simboli, non furono pubblicati che prima del 1955, ma senza trascrizione e traduzione.3 Attualmente, quasi cinquanta anni più tardi, solo una parte di questo materiale è stato pubblicato con relativa trascrizione e traduzione.
Parallelamente agli studi cronologici, ho lavorato ad una tesi di dottorato riguardante il sistema verbale dell’Ebraico Classico. Per questo lavoro avevo a disposizione un tempo limitato così ho rimandato il manoscritto sulla cronologia, e il mio proposito era quello di continuare il lavoro sul manoscritto dopo che la tesi fosse completata. In ogni caso, la cronologia non è solo una sorda e noiosa materia accademica, ma in particolare la cronologia delle nazioni attorno all’antico Israele, che interagisce con la cronologia biblica, è stata oggetto di molte discussioni, come si può notare da qualsiasi ricerca su internet. Ho ricevuto molte osservazioni sul mio lavoro da diverse parti del mondo, e per questo, ho ritenuto opportuno pubblicare il primo di questi due volumi contenente un dibattito sulla durata dell’esilio Babilonese degli Ebrei, argomento principale, e sulla cronologia Persiana.
Nel libro sarà dimostrato che non vi è modo di riconciliare la cronologia della Bibbia con il moderno punto di vista della cronologia Babilonese e Assira. La cronologia Persiana, con due grandi adattamenti e alcuni più piccoli, si conforma alla Bibbia. Lo scopo del libro non è quello di raggiungere una definizione finale su quale cronologia sia corretta o sbagliata. Nessuno schema cronologico rappresenta la verità finale. Lo scopo è quello di discutere punti di vista universalmente accettati e presentare i dati il più possibile strutturati in modo da portare il lettore ad una personale conclusione.
Da quando ho iniziato gli studi cronologici, il mio punto di vista è in parte cambiato. Ho iniziato a credere che quando gli esperti stabiliscono una data sulla base di osservazioni astronomiche di una tavoletta cuneiforme e la tavoletta collega una certa data con un particolare anno di uno specifico re, allora c’è una cronologia assoluta indiscutibile. Credo anche che le date Giuliane siano generalmente e correttamente stabilite dai moderni astronomi sulla base delle osservazioni sulle tavolette cuneiformi ma sono più scettico riguardo il rapporto di queste date con gli anni regnanti di antichi re, in particolare prima del 400 A.E.V.
Il punto di vista moderno della cronologia riguardante il mondo antico, si rifà agli scritti di Claudio Tolomeo. Venticinque anni fa, il geofisico R.R. Newton sollevò obiezioni accusando Tolomeo di truffa, poiché quest’ultimo sosteneva di aver fatto osservazioni quando invece aveva inventato calcoli a ritroso nel tempo. La ragione principale per il contrario giudizio di Newton era che le “osservazioni” di Tolomeo si adattavano perfettamente alla teoria astronomica, ma si adattavano solo approssimativamente alla reale posizione dei corpi celesti, con errori particolarmente visibili. I dati disponibili suggeriscono che una situazione simile esisteva anche nello schema cronologico dei re di Tolomeo. Questo schema si adatta perfettamente allo schema teorico delle eclissi dei cicli4 di Saros e dei mesi intercalari, ma fissa solo approssimativamente i regni dei reali re Persiani, Babilonesi e Assiri, con errori specifici.
Molti studi sull’argomento sono orientati a favore della cronologia tradizionale; lo schema generale non è in discussione, e lo scopo degli studi spesso è quello di confermare la cronologia accettata. Questo studio è piuttosto orientato nella direzione opposta; nessuno sforzo sarà compiuto per accordarsi alla cronologia approvata. Sfido la cronologia universalmente accettata di Parker e Dubberstein (1956), tracciata faticosamente da Tolomeo, affermando, per esempio, che il 51% dei loro mesi intercalari, siano senza fondamento. In ogni caso, mi sforzo di rivedere la cronologia tradizionale in un modo giusto ed equilibrato. Attualmente, risulta un vantaggio per la comunità scientifica avere schemi cronologici stabiliti analizzati in modo critico.
Il campo di cui mi occupo è la cultura e il linguaggio Semitico ed un elemento a mio favore è che sono in grado di leggere e lavorare su documenti originali in Ebraico, Aramaico, Greco e Accadico. Un elemento a sfavore è che non sono né un esperto astronomo archeologo, né uno storico. Inoltre, come ogni esperto sa, se non si è preparati in un campo, è più probabile commettere errori. Perciò non vedo l’ora di confrontarmi con critici in modo costruttivo e con suggerimenti di studiosi competenti.5 Il mio punto di vista, comunque, è fondamentalmente linguistico. Non sfido le conclusioni riguardanti i dati che gli archeologi astronomi tracciano sulla base delle tavolette astronomiche; critico solo alcune delle loro applicazioni e la necessità di avere una iniziale conoscenza astrologica da parte mia, è minima. Presento una nuova cronologia, che chiamo “Cronologia di Oslo”, la quale è un’alternativa alla cronologia tradizionale. Ma questo è solo un contributo e non ha la presunzione di essere assoluto. La vera importanza della Cronologia di Oslo è che non determina “la sola, vera cronologia”, ma piuttosto dimostra che nemmeno la cronologia accettata, basata su P&D, rappresenta “la sola, vera cronologia”. Per questo possono essere fatte interpretazioni cronologiche alternative.
NOTE
1. Il Norwegian Magister Artium Degree si pone tra l’American MA e il PH. D degrees, sebbene sia più vicino al Ph. D degree.
2. Una “cronologia assoluta” è una cronologia in cui particolari anni di regno di re sono legati ad osservazioni astronomiche.
3. J. A. Sachs, Late Babylonian Astronomical and Related Texts copied by T. G. Pinches and J. N. Strassmaier, Brown University Studies, Volume XVIII, Providence: Rhode Island: Brown University Press, 1955
4. La parola Saros si riferisce al simbolo cuneiforme Babilonese shar 40 che significa 60x60=3600. Nella moderna astronomia significa un periodo di 223 mesi (18 anni e 11 giorni) di eclissi lunari. Le eclissi accadono con intervalli di 5 o 6 mesi, e dopo 18 anni un nuovo ciclo con eclissi simili a quelle del periodo previsto, si verificano nuovamente. Tale periodo di 18 anni è chiamato ciclo di Saros
5. In particolare sono interessato alle tavolette dove l’analisi indica errori nelle traslitterazioni o trascrizioni pubblicate.
ABSTRACT
Capitolo 1: presenta tre importanti testimonianze del mondo antico: la Bibbia e due tavolette astronomiche, la VAT 4956 e la Strm Kambys 400. Queste tre fonti si contraddicono l’una con l’altra, perciò, lo scopo di questo studio è di scoprire quale di queste testimonianze deve essere certa di fornire informazioni corrette. Il capitolo descrive la differenza tra una cronologia assoluta e relativa ed esamina i diversi problemi che possono ridurre la veridicità di uno schema cronologico.
Capitolo 2: analizza il problema principale per la realizzazione di una cronologia assoluta, basata su tavolette astronomiche in cui sono menzionati uno o più anni riferiti ai re citati. Probabilmente la maggior parte della posizione dei corpi celesti su queste tavolette, è calcolata piuttosto che osservata realmente. Il problema è: come ci si può fidare di queste tavolette se non si possono distinguere le “posizioni” che sono state calcolate da quelle che sono state osservate? Viene discussa l’interazione tra la cronologia assoluta e relativa, e viene mostrato che la cronologia relativa può essere usata per verificare la precisione della cronologia assoluta.
Capitolo 3: analizza le caratteristiche del Sumerico, Accadico ed Ebraico che possono contribuire ad una giusta o sbagliata lettura delle tavolette cuneiformi.
Capitolo 4: confronta i resoconti cronologici di Claudio Tolomeo, Giuseppe Flavio e altri antichi resoconti cronologici elencandone i loro aspetti. I sei passaggi Biblici dove viene menzionato l’esilio Babilonese di 70 anni, vengono qui discussi nel dettaglio. Viene mostrato che alcuni testi sostengono inequivocabilmente che Gerusalemme fosse una distesa desolata durante questi 70 anni. In questo modo, un esilio di circa 50 anni, suggerito dalla cronologia tradizionale, è in contrasto con la Bibbia.
Capitolo 5: analizza le tavolette di Saros, le quali, si pensa, che verifichino la cronologia tradizionale Persiana una volta per tutte. Ma è mostrato che l’informazione sulle tavolette di Saros a volte è in contrasto con le tavolette commerciali datate e astronomiche, così esiste una cronologia calcolata artificialmente che non può essere certa. Viene esaminata l’enorme analisi cronologica di Parker e Dubberstein, mostrando che circa la metà dei mesi intercalari che il lavoro elenca riguardanti l’Impero Persiano, mancano di sicuro fondamento, e che la loro cronologia deve essere rifiutata in alcune sue parti importanti.
Capitolo 6: considera i primi tre re dell’Impero Persiano, Ciro, Cambise, Dario I, e i tre usurpatori al trono, Bardiya, Nabucodonosor III e Nabucodonosor IV. La prova evidente è che Bardiya dominò 18 mesi tra Cambise e Dario I anziché 7 mesi come universalmente creduto. Questo significa che il regno di Dario I cominciò nel 521 e non nel 522 A.E.V. Questo indica che entrambe le cronologie, quella di Saros e quella tradizionale, basate su Tolomeo, sono sbagliate.
Capitolo 7: esamina molte prove che indicano che Serse fu co-reggente con suo padre, Dario I, per 11 anni. Le iscrizioni, un diverso uso di titoli che riguardano Serse, e allo stesso modo, nel modello dei mesi intercalari per i primi 11 anni di Serse e negli ultimi 11 anni di Dario I, sono a favore di una co-reggenza.
Capitolo 8: analizza il regno di Artaserse I. Quando la durata del regno di Dario I viene fatta avanzare di un anno ed il regno di Serse è spostato indietro di 11 anni, questo significa che il regno di Artaserse I è spostato indietro di 10 anni. Così, l’anno di accessione fu il 475 e il primo anno di regno fu il 474 A.E.V. Di conseguenza il regno di Artaserse I fu di 51 anni e non di 41 come comunemente creduto. Viene mostrato come le tavolette commerciali datate, sostengano questo punto di vista, e come ciò sia vero con le testimonianze Greche, in particolare riguardanti Temistocle. La prova dell’Elephantine si schiera a favore del regno più lungo. La fine del regno di Artaserse I è stabilita nel 424, data della cronologia tradizionale, o il 423.
Capitolo 9: analizza il regno di Dario II, il cui regno è spostato avanti di un anno al 423, dando spazio per Serse/Sogdiano tra Artaserse I e Dario II. Gli ultimi re Persiani vengono solo discussi velocemente, perché nel loro caso, il punto di vista della cronologia tradizionale è accettato.
Capitolo 10: unisce tutti gli elementi insieme. L’inizio dell’impero Persiano nel 539 e la sua fine nel 330 è accettata da entrambe, sia la cronologia tradizionale che la Cronologia di Oslo, ma la Cronologia di Oslo differisce in quattro punti: c’è un anno in più per Bardiya prima di Dario I, una co-reggenza di Dario I e Serse di 11 anni, 51 anni di regno per Artaserse I, e un anno in più tra Artaserse I e Dario II posto tra Serse II/Sogdiano. Le due cronologie sono comparate graficamente nella tabella 35 per l’intero Impero Persiano dove viene mostrato il modello dei mesi intercalari. Alla fine vengono presentate le conclusioni.
INDICE
Contenuti Introduzione
Ringraziamenti
Abstract
Capitolo 1 Fondamentali considerazioni cronologiche
Il bisogno di un approccio equilibrato
Prove contro evidenza
Le basi per realizzare una cronologia
La cronologia relativa e i suoi problemi
La cronologia assoluta e i suoi problemi
Fattori connessi con gli scriba e tavolette che possono causare errore
La visione degli osservatori
Il processo di scrittura dei dati
La grossolanità delle osservazioni
Il luogo delle osservazioni
La durata del mese
L’anno lunare contro l’anno solare
L’accettazione di uno schema “adattato”
Quale calendario fu usato?
Nessuna severità nell’accuratezza delle osservazioni
Il lavoro degli studiosi moderni
Capitolo 2: La prova al tornasole della cronologia Assoluta
Osservazione contro calcolo
L’interazione tra cronologia assoluta e relativa e “l’effetto domino”
“L’effetto domino” e i diari astronomici
“L’effetto domino” e le tavolette di Saros
Capitolo 3: Il linguaggio e la scrittura dei documenti originali
Simboli Sumerici e linguaggio
Simboli Accadici e linguaggio
Una possibile identificazione di Nimrod
I numeri Accadici
La lettura e la comprensione dell’Accadico da parte di studiosi moderni
La lettura delle tavolette può risultare inesatta
Possibili errori di lettura causati dalla pressione cronologica
I linguaggi Aramaico ed Ebraico ed i loro simboli
Numeri in Ebraico ed Aramaico
Questioni filologiche riguardanti il testo della Bibbia
Capitolo 4: I vecchi resoconti cronologici dei re Neo Babilonesi
Resoconti cronologici in lingua Greca
La Bibbia: 70 anni di schiavitù Babilonese
I 70 anni di desolazione della terra
Qual’era l’obiettivo di Geremia?
Le parole di Zaccaria
Un tentativo teologico di armonizzare la Bibbia
con la cronologia tradizionale
I due poli della cronologia Babilonese
Capitolo 5: La debolezza della cronologia tradizionale Persiana
Il ciclo di Saros e i mesi intercalari
Tentativi di stabilire i cicli di Saros prima del 747
Il significato delle tavolette di Saros
Le Tavolette di Saros non possono essere utilizzate per realizzare una cronologia assoluta
Problemi relativi all’uso delle Tavolette di Saros in rapporto ad una cronologia relativa
Quanti mesi intercalari sulle Tavolette teoriche di Saros, sono confermate da fonti indipendenti?
L’informazione delle Tavolette di Saros e il ciclo di 19 anni
Un serio problema legato alle tavolette commerciali datate
I mesi intercalari confermati
I mesi intercalari e le tavolette provenienti da Persepoli
La qualità dello studio realizzato da Parker e Dubberstein
Quantità contro qualità
Una selettiva gestione dei dati
Ciro
Cambise
Dario I
Quanti tra i mesi intercalari, a cui fanno riferimento P&D, hanno fondamento?
Mesi intercalari incerti sulle tavolette astronomiche
Mesi intercalari incerti sulle tavolette commerciali
Una sintesi delle prove
La critica di P&D
Conclusioni riguardanti il punto debole della cronologia di Tolomeo e delle Tavolette di Saros
Capitolo 6: Ciro, Cambise, Dario I, Bardiya e la cronologia iconoclasta
Ciro (II) – il primo re dell’Impero Persiano
Cambise, figlio di Ciro – secondo re di Persia
La natura della Strm Kambys 400
Dario I – il portatore di lance che salì al potere
L’iscrizione Behistun
Bardiya e le sue tavolette bucano la cronologia di Tolomeo
L’autenticità delle tavolette datate attribuite a Bardiya
Le tavolette datate applicate ai quattro re L’interpretazione delle tavolette datate
La prova riguardante Bardiya non è generalmente accettata
Nabucodonosor III e Nabucodonosor IV – sono esistiti?
Un’interpretazione delle possibili tavolette di Nabucodonosor III e Nabuconodors IV
Nabucodonosor III e Nabucodonosor IV sono esistiti?
Cosa dire riguardo gli altri re dal nome Nabucodonosor?
Considerazioni finali sulla successione al potere di Dario I
Capitolo 7: Il regno di Serse e la sua coreggenza con il padre Dario I
Le tavolette mostrano che il 36° anno di Dario non era l’anno di accessione di Serse
Iscrizioni e incisioni suggeriscono una co-reggenza
Una co-reggenza suggerita da un cambiamento nei titoli usati
Una verifica importante: i mesi intercalari coincidono con gli anni ipotizzati di una co-reggenza?
Conclusioni riguardo una possibile co-reggenza
Capitolo 8: Un punto di vista alternativo riguardo il regno di Artaserse I
Documenti commerciali e altre tavolette datate
Tavolette astronomiche collegate con il regno di Artaserse I
Alcune considerazioni sui principi di datazione
I diari astronomici
Alcune prove Greche
Alcune prove Egiziane
L’ informazione dei papiri duplicemente datati
Problemi con testo e datazione
Capitolo 9: Dario II e gli ultimi re dell’Impero Persiano
Le testimonianze astronomiche nel regno di Dario II
I dati di Venere
Congiunzione di Marte, Saturno e Luna
Osservazioni dei pianeti
La successione dei mesi intercalari da Artaserse I a Dario II
Capitolo 10: Una comparazione tra la Cronologia di Oslo e la Cronologia Tolemaica
Un’analisi dei modelli
La fonte artificiosa della cronologia Tolemaica
Volume II: Cronologia Assira, Babilonese, Egiziana