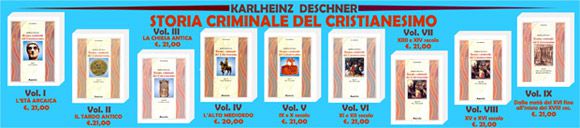RETROCOPERTINA
Questo libro è qualcosa di più di una storia obiettiva e serena dello sviluppo teologico dei primi secoli. Se chiarezza e concisione, documentazione e senso della prospettiva fossero le sue sole qualità, l'opera non andrebbe al di là dell'ideale, seppur rara, impresa scientifica. Ciò che invece lo caratterizza rispetto al «genus» della «Dogmengeschichte» e che ne costituisce il pregio maggiore è ad un tempo l'armoniosa tessitura e il doppio versante metodologico.
Il libro è infatti solcato, nella sua mappa, da due generi di direttive che ne determinano i punti di riferimento e ne fissano la materia: quella disgiuntiva, cronologica (che divide il pensiero preniceno da quello postniceno) e geografica (che distingue il pensiero latino da quello greco); e quella congiuntiva, in cui lo sviluppo omogeneo delle definizioni dogmatiche viene efficacemente messo in luce, sia in senso orizzontale (lo sviluppo dei dogmi attraverso le epoche) sia in senso verticale (lo sviluppo del dogma al suo proprio interno).
La compattezza del volume non impedisce l'emergere, con chiarezza, di un filo conduttore. Anche se quest'opera non si domanda esplicitamente quale sia il «principio interpretativo» o la formula teorica unitaria sotto la quale assumere i vari fenomeni del pensiero cristiano delle origini (come hanno fatto Harnack e Werner, rispettivamente con la teoria dell'ellenizzazione e della de-escatologizzazione del cristianesimo), articola purtuttavia una chiara risposta quando riconosce il ruolo unificante, costante e salutare, della regola della fede.
Aspetti e problemi
della moderna storia dei dogmi
« Scrivendo questo libro - avverte il Kelly nella prefazione alla prima edizione - il mio modesto scopo è stato quello di offrire agli studiosi e a quanti altri vi s'interessano, uno schema generale dello sviluppo teologico che ha avuto luogo nella Chiesa dei Padri ». Bisogna tener presente a ogni istante questa dichiarazione dell'autore per valutare correttamente la sua opera e non rischiare di rimanere ingiustamente delusi dalla sua lettura.
L'intento eminentemente pratico-scolastico -nel senso migliore del termine - della presente opera è confermato dalla rinuncia a quelle lunghe e impegnative trattazioni preliminari sul significato della storia dei dogmi, sul metodo, sul rapporto tra dogma e teologia, ecc., che occupano invece solitamente un posto di rilievo nei grandi manuali di storia dei dogmi di origine tedesca. Il titolo stesso dell'edizione originale, Early Cbristian Doctrines, indica la volontà dell'autore di mantenere una certa indipendenza di fronte al genere fortemente tipizzato della Dogmengeschichte, rimanendo piuttosto nell'alveo della tradizione anglicana (rappresentata in questo campo per oltre mezzo secolo dalla Early History of Cbristian Doctrine di Bethune-Baker)1 la quale preferisce parlare di «dottrine» anziché di «dogmi», secondo una terminologia che richiama da vicino quella del Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana di J. H. Newman.
Senza teorizzare al di là delle intenzioni dell'autore questa scelta di vocabolario, è lecito far notare come essa abbia il vantaggio di evitare la contrapposizione tra dogma e teologia abbracciando l'uno e l'altra.
La questione del rapporto tra dogma e teologia era stata posta in maniera acuta e brillante dallo Harnack all'inizio del suo Lehrbuch der Dogmengeschichte2. Ma sia lui che il suo discepolo F. Loofs3 si erano poi sottratti alla logica di tale distinzione, mantenendo alle loro opere il titolo di Dogmengeschichte, nonostante risultasse fortemente riduttivo rispetto al reale contenuto delle loro trattazioni.
La cosa va tenuta presente in quanto coinvolge una questione fondamentale per ogni storia del pensiero cristiano. Il dogma è l'esponente o la base della teologia? Harnack, che sollevò per primo questo problema, fonda l'intera sua ricostruzione sulla prima alternativa. «I dogmi - scrive - sono il prodotto della teologia e non viceversa e la teologia, in linea generale, fu il prodotto dello spirito del tempo»4.
Se non che i dogmi, una volta costituiti e sanciti dalla Chiesa, tendono ad assoggettare la teologia riducendola al rango assai modesto di difesa e baluardo del dogma e loro avvocato difensore. Subirebbe, in altre parole, la sorte di una madre che viene fatta schiava dai figli che ha messi sul trono. Questo spiegherebbe perché Origene, che dal punto di vista teologico fu il padre del dogma trinitario, venne poi condannato in nome dello stesso dogma.
Una tale interpretazione della dialettica tra dogma e teologia ha indubbiamente un suo fascino, soprattutto se confrontata con un certo tipo di interpretazione ecclesiastica di vecchio stampo secondo la quale all'origine (come base!) c'è il dogma rivelato, già precostituito, che rappresenta la sostanza della fede, alla quale la teologia non darebbe se non la forma, lavorando semplicemente alla sua formulazione e alla sua promulgazione.
Ma c'è un terzo modo di concepire il rapporto, secondo cui il dogma è, nello stesso tempo, ma in gradi diversi di esplicitazione, base ed esponente della teologia, suo punto di partenza e suo coronamento. Chi ammette questo terzo modo non concluderà che le definizioni dommatiche siano frutto della teologia e non della rivelazione, solo perché Nicea e Calcedonia vengono dopo gli Apologisti e Origene.
Come si vede, il problema della priorità tra teologia e dogma non è che un modo particolare di formulare l'altro problema più vasto e più famoso: quello dello sviluppo o della creazione dei dogmi. Se lo si accenna in questa sede, nonostante la cura del Kelly di tenerlo fuori dalla sua preoccupazione di storico, è perché di fatto egli non è, né poteva essere, neutrale di fronte a tale problema. Studiare, anzi, la sua collocazione all'interno di esso significa scoprire il principio che dà coerenza e unità a tutta la sua ricostruzione del pensiero cristiano antico.
Da cento anni circa a questa parte si sono venuti delineando due modi diversi di fare la storia della dottrina o dei dogmi cristiani. Il primo modo, il più noto, è quello portato avanti in seno al protestantesimo dal genere della Dogmengeschichte, legato ai nomi di A. von Harnack, di F. Loofs, di M. Werner e di altri ancora.
La caratteristica fondamentale di questo tipo di manuale è l'assunzione di un principio interpretativo, alla luce del quale l'intero sviluppo del dogma è visto e giudicato5. Ricordiamo tre casi paradigmatici.
A. von Harnack scorgeva tale principio interpretativo nella progressiva ellenizzazione del messaggio cristiano, parallela a una sua degiudaizzazione. «Nel suo concetto e nel suo sviluppo - egli scriveva - il dogma è l'opera dello spirito ellenico che lavorò sul terreno del Vangelo»6. Nelle edizioni della sua Dogmengeschichte successive alla prima egli lamentava il fatto che i suoi critici avessero falsato su questo punto il suo pensiero, eliminando o sottovalutando la sua precisazione «sul terreno del V angelo ». Ma si può dire che tale precisazione modifichi sostanzialmente il problema? Se il dogma è frutto dello spirito greco che lavorò sul Vangelo, il Vangelo è promosso, tutt'al più, al ruolo di causa materiale, ma non sarebbe mai, in ogni caso, la causa formale della teologia della Chiesa; sarebbe locus theologiae, il terreno della teologia, non locus theologicus, cioè il criterio e la fonte della teologia.
Dopo Harnack la ricostruzione del dogma antico nella quale è più evidente l'assunzione di una teoria dello sviluppo del dogma è l'opera di M. Werner7. Werner mantiene la tesi di Harnack dell'ellenizzazione del cristianesimo, ma la integra con un altro grande principio emerso nel frattempo in primo piano, negli studi sulle origini del cristianesimo, ad opera di A. Schweitzer: l'escatologismo. La dommatica della Chiesa è frutto dell'ellenizzazione, ma l'ellenizzazione non è che l'altra faccia o, se si vuole, la conseguenza della descatologizzazione del messaggio evangelico. La mancata realizzazione della parusia, a dire di Werner, avrebbe indotto i pensa tori cristiani ad elaborare un sistema di dottrine che mettessero la Chiesa in condizione di inserirsi nell'establishment culturale del tempo. Si tratta di una estensione al tempo e alla teologia della Chiesa di quella «escatologia consequenziale» che A. Schweitzer (al quale apertamente il Werner si richiama) aveva applicato per spiegare il Nuovo Testamento e, in particolare, la formazione dell'idea di una storia della salvezza8.
Pur non presentandosi esplicitamente come una storia dei dogmi, merita di essere ricordata a questo punto, come terzo esempio di una ricostruzione sistematica del pensiero cristiano antico, l'opera di H. A. Wolfson, The Philosophy of the Cburcb Fatbers9. Egli vede lo sviluppo delle principali dottrine cristiane (Trinità e Incarnazione) come un momento dell'evoluzione della filosofia antica mediato dal pensiero di Filone Alessandrino. La cesura tra mondo antico e cristianesimo è stemperata in una serie di passaggi indolori e il cristianesimo appare come il continuatore e l'erede, ben più che l'antagonista o anche semplicemente il partner della filosofia greca10.
Questi tentativi di illuminare dall'alto di un'idea o di un principio l'intero sviluppo del pensiero cristiano antico, a giudizio pressoché unanime degli studiosi di oggi, sono falliti e sono falliti soprattutto per la loro incapacità di configurarsi come criteri storici e per la loro tendenza a introdurre una dommatica in seno alla stessa storia del dogma. Di fronte a questi risultati, un noto storico protestante ha commentato: «Solo là dove c'è una tradizione dottrinale della Chiesa, dommaticamente stabilita, come nel cattolicesimo e nell'anglicanesimo, il cammino della ricerca va avanti incontrastato, senza tuttavia essere in grado di elaborare punti di vista nuovi e decisivi»11.
Questo ci introduce a parlare del secondo modo con cui è possibile fare (e si è fatta in realtà) la storia del dogma. Secondo il giudizio, a mio parere esattissimo, dello studioso appena citato esso è comune ai cattolici e agli anglicani ed è caratterizzato dall'accettazione del principio di tradizione. Tra gli anglicani l'esempio pio riuscito e pio noto, prima del Kelly, è dato dalla già ricordata Early History of Christian Doctrine di J. F. Bethune-Baker e tra i cattolici dalla Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne di J. Tixeront12.
Questi manuali si propongono un obiettivo pio modesto. Si preoccupano molto pio di ricostruire lo sviluppo del dogma che non di fornire, in sovrappiù, anche una teoria dello sviluppo; si sforzano di fare la storia del dogma, pio che l'interpretazione della storia del dogma. La lettura di questi ultimi manuali è senza dubbio meno affascinante e al loro apparire essi non hanno suscitato quell'alone di interesse e di dibattito teologico spesso fecondissimo che ha accompagnato alcune celebri storie dei dogmi tedesche dell'Ottocento e del primo Novecento. Qual è allora il loro scopo e il loro vantaggio? Esso può forse essere sintetizzato con un concetto: l'oggettività. Mi rendo conto che l'oggettività, in questo campo, è essa stessa qualcosa di estremamente « soggettivo» e variamente valutabile. Non si può misconoscere, tuttavia - l'esperienza stessa si è incaricata di dimostrarlo -, che l'assunzione di un principio di interpretazione, oltre a costituire una specie di letto di Procuste per la storia dei dogmi, ha significato anche spalancare la porta al soggettivismo, soprattutto a quel soggettivismo che deriva allo storico da una apertura troppo confidente agli indirizzi culturali ed esegetici in voga al momento in cui scrive. Sotto questo profilo, il genere della Dogmengeschichte ha ricalcato, per taluni aspetti, la vicenda e le oscillazioni della Leben-Jesu Forschung. La teologia liberale di stampo ritschliano ha prodotto la Dogmengeschichte di Harnack (e in parte di Loofs), e la scuola escatologica quella di Werner, esattamente come, in epoca anteriore, la filosofia hegeliana della storia aveva prodotto le varie storie dei dogmi di F. Ch. Baur (Tubingen, 1847), di G. Thomasius (Erlangen, 1874-76) e di altri ancora. Forse sarebbero maturi i tempi per una Geschichte der Dogmengeschichten, per una «Storia delle storie dei dogmi» che assolvesse, in questo campo, lo stesso compito chiarificatore che assolse lo Schweitzer con la sua Geschichte der Leben-Jesu-Forschung13. Questo tipo di soggettivismo che ha reso sempre problematico il ricorso alle grandi storie dei dogmi di estrazione liberale, se non è assente del tutto (sarebbe illusorio crederlo), è certamente meno accentuato nei manuali che rinunciano a un principio di interpretazione personale che non sia quello della tradizione.
A questo punto il nostro discorso si può concentrare sull'opera del Kelly. La sua posizione su alcuni dei problemi sollevati nelle pagine precedenti è espressa nella prefazione della prima edizione inglese, quando scrive: «Non ho tentato di definire la natura intrinseca dell'ortodossia14 né di determinare l'incidenza dell'ellenismo sul Vangelo originario... ma mi sono contentato di esporre le dottrine in se stesse con tutta la comprensione e l'imparzialità possibile».
Che l'autore abbia conseguito alla perfezione questo suo intento è stata l'opinione unanime degli studiosi di patristica. La concisione e la chiarezza fanno del suo volume un ideale libro di testo per lo studio della patristica e, possiamo aggiungere, anche l'unico oggi disponi.
bile sul mercato che possa assolvere tale compito, se intendiamo patristica nel suo significato specifico di studio delle dottrine dei Padri, per il quale si distingue tanto dalla patrologia che dalla storia della letteratura cristiana antica. Anche lo studioso e il ricercatore vi ricorrono sempre con frutto quando hanno bisogno di abbracciare in un rapido sguardo d'insieme un problema, una dottrina, un periodo dello sviluppo del pensiero patristico. Lo sforzo di ripensa mento personale e di essenzializzazione dell'enorme materiale realizzato dall'autore fa sì che chi vi ricorre dopo aver letto più diffusi lavori monografici su un dato argomento abbia l'impressione di ritrovare tutto nelle sue pagine.
L'intera materia è solcata da due grandi coordinate che ne determinano una distribuzione logica ed efficace guanto storicamente valida: la coordinata cronologie a che divide il pensiero preniceno da quello postniceno e la coordinata geografica che distingue il pensiero latino da quello greco15. (Assente, purtroppo, come nella maggior parte di lavori del genere, resta il pensiero patristico orientale pure non estraneo, specie quello siriaco, allo sviluppo del dogma). Un vantaggio di questa disposizione è di mettere in evidenza immediatamente il diverso contributo della teologia greca e di quella latina e la loro diversa reattività di fronte alle dottrine evangeliche. Nonostante certe felici (ma quanto consapevoli?) anticipazioni terminologiche dei latini, e in particolare di Tertulliano, l'elaborazione della dottrina trinitaria e più ancora di quella cristologica appare opera soprattutto dei greci, mentre la dottrina della Chiesa, della grazia e dei sacramenti ha trovato il suo epicentro, almeno dopo Nicea, in occidente tra i latini. La ragione di ciò non può essere ricondotta totalmente alla presenza in tale momento tra i latini di quel genio che si chiama Agostino, ma va anche ricercata nel diverso grado di applicabilità del bagaglio filosofico greco ai due ordini di dottrine. All'interno di questa grande suddivisione, il Kelly è riuscito a distribuire la materia in unità organi- che susseguentisi in maniera logica e armoniosa, in modo da riflettere il più fedelmente possibile il reale svolgersi della riflessione teologica all'interno di una dottrina (Trinità, cristologia, soteriologia, ecc.) e la vitale connessione delle varie dottrine tra loro. Una riserva va forse avanzata per la trattazione dell'escatologia posta tutta intera alla fine e, non si capisce perché, sotto forma di Epilogo. Sul problema dell'escatologia, oltre questo rilievo sulla sua collocazione, ci sarebbe forse da avanzarne un altro relativo al contenuto stesso. Essa è trattata, infatti, più alla stregua del tradizionale De novissimis che non alla luce della più recente problematica escatologica elaborata dagli studi biblici. La sintesi che Kelly ci offre in tale Epilogo è, come al solito, impeccabile per la capacità di individuare e dare il giusto rilievo ai tempi forti di una dottrina, compito particolarmente arduo in questo caso, mancando il solito riferimento a controversie e definizioni conciliari che si hanno invece in altri campi. Ma il taglio scelto lascia fuori del tutto uno degli aspetti più interessanti legati alla escatologia: la concezione cristiana del tempo e della storia e quindi anche della storia della salvezza16.
Interessante e nuovo è il metodo usato dal Kelly per la documentazione. Egli sceglie per ogni autore, o momento della sua ricostruzione, i testi più significativi dei Padri, li riassume fedelmente nel testo, riportando talora nella lingua originale i termini e le formule di maggior rilievo, limitandosi a dare in nota la sola citazione della fonte antica. Il risultato è che si ha veramente l'impressione che siano i Padri a spiegare essi stessi con parole proprie il loro pensiero. I casi di autori moderni inseriti nel vivo della discussione e della ricostruzione storica si contano letteralmente sulle dita. In compenso, alla fine di ogni capitolo è fornita una « nota bibliografica» generalmente ben selezionata17.
Si tratta di un metodo senza dubbio semplificatore, ma tutt'altro che di comodo. Esso è anzi fra tutti quello che costringe l'autore ad assumersi la maggior quantità di lavoro e a lasciarne il meno al lettore. Ciò che viene offerto è un materiale già predigesto.
Naturalmente c'è un pericolo anche in ciò e non è mancato chi lo ha fatto osservare18. Il pericolo di semplificare troppo le questioni, ricadendo così, per tutt'altra via, nel rischio del soggettivismo. Pur riconoscendo infatti all'autore, in grado sommo, acume interpretativo dei' testi, informazione bibliografica e sforzo di obiettività, ad ogni istante quello con cui il lettore si trova ad essere confrontato sono in fondo le soluzioni e le scelte interpretative dell'autore, senza una possibilità di verifica immediata che non passi attraverso la lettura dell'intera bibliografia riunita a fine capitolo, ciò che non potrebbe sostituire, in ogni caso, il compito di una confrontazione capillare delle opinioni. Coloro per i quali il libro del Kelly costituisce il primo e l'unico strumento di accostamento del pensiero patristico (e sono i più, trattandosi di un lavoro largamente adottato come testo scolastico in seminari ed università) dovranno guardarsi dal credere che esista ormai un accordo di massima su tutte le questioni della teologia patristica. Il dibattito, al contrario, è più che mai vivace e aperto su molti punti anche centrali dello sviluppo del pensiero cristiano antico e la scienza storica è ben lontana ancora dall'averlo rischiarato in tutte le sue pieghe.
Nella seconda edizione inglese del libro, resasi necessaria (cosa assai significativa per questo genere di libri!) ad appena un anno di distanza, l'autore raccoglieva questa obiezione, riconoscendo l'urgenza di una maggiore discussione sulle soluzioni dottrinali, ma aggiungeva di non ritenere che ciò fosse compito di un lavoro storico come quello che egli aveva voluto scrivere. Forse la risposta ultima è che si è trattato di una scelta e come ogni scelta anche questa ha comportato una rinuncia: la rinuncia ad una maggiore problematizzazione che, se avrebbe arricchito e vivacizzato il discorso, difficilmente avrebbe permesso di mantenere inalterata la chiarezza e la sobrietà, le qualità cioè più volentieri ammirate nel manuale del Kelly.
Personalmente, sono incline ad attribuire maggiore rilevanza a un'altra obiezione: quella del punto di partenza della storia del dogma19. Il Kelly inizia la sua ricostruzione del pensiero cristiano antico con l'era sub-apostolica, fuori cioè del Nuovo Testamento, dopo aver premesso dei prolegomena sull'ambiente culturale e religioso in cui nasce il cristianesimo. Motivi che possono avvalorare questa scelta ve ne sono certamente. Tuttavia, credo he abbia ragione il Grillmeier quando afferma che una storia del dogma oggi non possa prescindere da un quadro, sia pure introduttivo e sommario, delle dottrine del Nuovo Testamento. A suo modo, tenuto conto cioè del punto in cui era a suo tempo la teologia biblica, un tale innesto tra teologia biblica e teologia ecclesiastica fu tentato già dal Tixeront20. Fare diversamente potrebbe equivalere a risalire un fiume in esplorazione e fermarsi prima di essere giunti alla sua sorgente. Ciò che lo esige non è tanto la necessità di mostrare la continuità o la di scontinuità tra kerygma e dogma – che esigerebbe un di spiegamento ben maggiore di mezzi e di spazio -, ma piuttosto un'altra considerazione. Oggi sappiamo che c'è un processo di teologizzazione del kerygma ben anteriore all'explicit del Nuovo Testamento ed è sommamente istruttivo studiare i caratteri e la direzione di tale processo per essere in grado di meglio valutarlo quando esso ci si ripresenta nella teologia della Chiesa. Il cosiddetto processo di ellenizzazione o di ontologizzazione della eristologia, per fare un esempio, richiede una diversa valutazione, una volta costatato che esso è già in atto e, per così dire, canonizzato all'interno del Nuovo Testamento nel passaggio dalla cristologia della primitiva comunità palestinese alla cristologia del giudaismo ellenistico e da questa alla cristologia della comunità ellenistica della gentilità21.
Probabilmente, una saldatura di questo tipo tra teologia neotestamentaria e teologia patristica farebbe apparire inesatto, o almeno assai sommario, il luogo comune che oppone la cristologia del Nuovo Testamento a quella della primitiva Chiesa come una cristologia storico-salvifica o funzionale a una cristologia ontologica.
C'è una cristologia ontologica nel Nuovo Testamento, come, d'altra parte, c'è una cristologia funzionale nella Chiesa patristica. Il bisogno di integrazione e di saldatura, del resto, è reciproco. Anche il biblista, infatti, si rende sempre meglio conto della necessità di spingersi verso il tempo della Chiesa, se vuole capire il senso e la direzione di certi processi o anche di certi concetti rilevati e seguiti nell'arco della rivelazione neotestamentaria. Ne è un esempio lo spazio sempre maggiore che il lessico del Kittel è venuto via via riservando, nei suoi articoli, alla letteratura sub-apostolica22.
Rimanendo sempre nell' ambito delle considerazioni di metodo, c'è un altro aspetto del lavoro del Kelly che mi pare utile mettere in rilievo perché aiuta a scoprire una dimensione più profonda che non sia quella della semplice ricostruzione storica. A prima vista - si è detto - il lavoro si presenta come un digestum della teologia patristica, il cui pregio maggiore sembra essere quello di abbracciare il maggior numero di dati e di problemi nel minor spazio possibile; minore, in ogni caso, in confronto con tutti i manuali confratelli che lo hanno preceduto, compreso quello di Bethune-Baker. Ma ciò non dà ragione della vera indole del libro e della sua ragion d'essere e, oltre tutto, da solo basterebbe appena a compensare i rischi e gli inconvenienti fin troppo noti di questo come di ogni altro manuale. Tale ragion d'essere è da scorgere, a mio avviso, in una dimensione essenziale del pensiero teologico antico che per tal 'via - e soltanto per essa - può essere messa in luce e compresa: la sua continuità. Una continuità che - con una terminologia stereotipata, ma sempre efficace - potremmo definire orizzontale e verticale nello stesso tempo. La continuità orizzontale (quella per la quale non esiste soluzione o cesura di sorta tra una regione e l'altra della teologia), COS1 caratteristica del pensiero patristico, è messa in evidenza in questa sintesi del Kelly (per quanto ciò è possibile una volta che si è perso il sentimento della globalità del mistero cristiano ed è sopravvenuta la lottizzazione del discorso teologico in «trattati»), in quanto i vari dogmi - Trinità, cristologia, soteriologia, ecclesiologia, dottrina sacramentaria, ecc. - sono qui esaminati e innestati l'uno sull'altro in modo più ravvicinato e più capillare che in qualsiasi altro tipo di ricostruzione d'insieme23.
La continuità verticale - quella cioè che unisce i vari stadi successivi di sviluppo all'interno di ogni singolo dogma (e per la quale, appunto, si ha diritto di parlare di « sviluppo» dei dogmi) - è posta fortemente in risalto dal ruolo che l'autore assegna, nello svolgimento del pensiero patristico, alla Tradizione della Chiesa. Questa costituisce, a mio avviso, l'anima nascosta e il filo conduttore che dà unità a tutta la sintesi. Da questo punto di vista, non è neppure del tutto esatto affermare che questo tipo di manuale di storia dei dogmi non presenta alcun principio di interpretazione. forse è più esatto dire che tale principio esiste, anche se diverso da tutti quelli cui si è accennato in precedenza, ed è appunto il riconoscimento del ruolo della Tradizione nello sviluppo della dottrina cristiana. La diversità di tale principio, per rispetto a ogni altro, è che esso non è applicato retrospettivamente a partire da una certa situazione culturale moderna, ma è vivo e operante nella coscienza stessa di coloro che di quella stessa dottrina furono i protagonisti dello sviluppo.
Secondo W. Miinscher - che può essere considerato il fondatore del genere della Dogmengeschichte liberale - la storia del dogma ha per scopo quello di mostrare le «innumerevoli mutazioni che l'elemento teorico della religione cristiana ha registrato dalla sua fondazione in poi»24. Questa definizione mal si applicherebbe al manuale del Kelly, il quale mostra piuttosto la continuità e lo sviluppo organico delle dottrine cristiane che non il loro supposto ricambio nel passaggio da un'epoca all'altra. In questo senso si diceva all'inizio che egli, pur evitando di impegnarsi in una ennesima discussione sul problema dello sviluppo o della creazione dei dogmi, non resta neutrale di fronte ad esso. Il riconoscimento della Tradizione costituisce per se stesso una presa di posizione su tale problema.
Quando parlo del ruolo della Tradizione nella ricostruzione del Kelly non mi riferisco naturalmente al breve capitolo dei Prolegomena in cui si tratta della dottrina dei Padri intorno alla Tradizione, quanto piuttosto alla applicazione di tale principio da parte dell'autore nel ricostruire e valutare le dottrine dei Padri. Un'applicazione, invero, assai discreta, quasi un atteggiamento e un punto di riferimento, più che una tesi chiaramente formulata alla maniera dei Deuteprinzipien dell'ellenizzazione o della descatologizzazione. Essa, tuttavia, non sfugge al lettore attento che non ricorre soltanto fugacemente, per semplice consultazione, a qualche pagina del libro, ma lo legge di un sol fiato e per intero.
Uno degli indici più manifesti del ruolo assegnato alla «traditio Ecclesiae» è il diverso peso che assume la testimonianza di origine ecclesiale, cioè dei pastori della Chiesa, rispetto a quella delle fonti apocrife, popolari o para-ecclesiastiche. Su questo punto, il manuale del Kelly differisce da quelli di Harnack e di Werner allo stesso modo che, sul piano letterario, la Gescbicbte der altkir-chlichen Literatur di Bardenhewer differisce dalla Gescbicbte der altchristlicher Literatur di Harnack25.
Quando il nostro autore afferma che se la gnosi non è arrivata a soppiantare la Tradizione, ciò è dovuto « in larga misura a un attaccamento indefettibile alla regola di fede come essa era formulata nella liturgia, nella catechesi e nella predicazione» (p. 176), viene a riconoscere alla Tradizione vivente della Chiesa un ruolo attivo nella storia del dogma. Si potrebbe verificare ancor meglio il ruolo attribuito alla Tradizione e alla «fides Ecclesiae» analizzando l'intero capitolo IV che tratta della dottrina trinitaria nel primo e secondo secolo. Taluno potrebbe perfino avere l'impressione che esso non faccia emergere nella loro reale dimensione le incertezze che caratterizzano i primi passi della teologia cristiana in questa direzione, per es. negli Apologisti greci, e che la preoccupazione di seguire il «filone centrale» della Tradizione lasci fatalmente nell'ombra delle impostazioni «laterali» del problema trinitario che pure hanno avuto la loro importanza nello svolgimento della riflessione teologica26.
Mi pare, tuttavia, che a parte questi inconvenienti, in parte inevitabili data l'indole del manuale, non si possa negare la fondatezza del punto di vista del Kelly quando mette in evidenza la coesistenza, a una certa fase dello sviluppo di una dottrina, di un dato di fede tradizionale della Chiesa (magari non formulato o mal formulato) con il silenzio o, addirittura, con l'assenza di ogni riflessione teologica cosciente su quel dato stesso. È a questo punto e su questa ammissione che si decide il problema della continuità o discontinuità tra kerygnra e dogma, il problema del rapporto tra base ed esponente nella teologia, per tornare al linguaggio di Harnack.
Le mie riflessioni si sono limitate fin qui al metodo dell'opera. Si potrebbe, volendolo, impostare una discussione anche sui suoi contenuti. Ma la ritengo di scarsa utilità ai fini della comprensione del libro. Il lettore già versato in materia potrà non riconoscersi in questa o quella soluzione adottata dall'autore. L'importante, tuttavia, è che, pur trattandosi di una storia dei dogmi, il motivo di un eventuale dissenso non è quasi mai di natura confessionale. Questo non solo testimonia della rara obiettività storica dell'autore, ma attesta, altresì, quale enorme patrimonio comune le varie confessioni cristiane - e in particolare quella cattolica e quella anglicana - possiedano nel Pensiero cristiano delle origini.
RANIERO CANTALAMESSA
NOTE
1. Edita per la prima volta a Londra nel 1903 l'opera ha avuto numerose edizioni e ristampe fino ai nostri giorni.
2. A. von Harnack, Lebrbucb der Dogmengescbicbte, Tùbingen, 1931, vol. I, pp. 12 ss.
3. F. Loofs, Leitladen zum Studium der Dogmengescbicbte, 5° ed. riveduta da K. Aland, Halle, 1950, vol. I, p. 9.
4. Harnack, op. cit., p. 12.
5. Cfr. A. Grillmeier, Ilellenisierung - judaisierung des Cbristentums als Deuteprinzipien der Gescbicbte dcs kirchlichen Dogmas, in «Scholastik», XXXIII (1958), pp. 321-355, 528-558
6. Harnack, op. cit., p. 24.
7. M. Werner, Die Entstebung des christlicben Doginus problemgescbicbtlicb dargestellt , Bern-Leipzig, 1941; 2° ed., Tiibingen, 1954; edizione inglese ridotta: Tbe Formationof Cbristian Dogma. An Historical Study of lts Problem, London, 1957.
8. Cfr. O. Cullmann, lleil als Gcschicbte, Tubingen, 1965; trad. it. Il mistero della redenzione nella storia, Bologna, 1966. pp. 31·78.
9. Carnbridge, Mass., 1956.
10. Interessante a questo proposito notare la collana della quale l'opera fa parte e che porta il titolo: Struttura e suiluppo dei sistemi filosofici da Platone a Spinoza.
11. C. Andrcsen, Zur Dogmengescbicbte der alten Kircbe, in «Thcolonische Litcrannzeitung», LXXXIV (1959), p. 82. Lo stesso studioso ribadiva questo concetto recensendo il volume del Kelly: «Il lavoro del Kelly dimostra per l'anglicanesimo. come fa il manuale di storia dei dogmi di Schrnaus per il cattolicesimo, che le maggiori possibilità di ricostruzione per la storia dei dogmi si hanno là dove il principio della tradizione perdura inoppugnato, come norma teologica domrnatica» («Theologische Literaturzeitung». LXXXV [1960], p. 597).
12. Il manuale del Tixeront in 3 voll. (fino al sec. IX) vide la luce in un momento difficile per coloro che all'interno della Chiesa cattolica tentavano di fare un discorso storico sul dogma (la prima edizione risale al 1904!) ed ebbe non poco merito nel dare alla storia del dogma diritto di cittadinanza nell'insegnamento cattolico della teologia, come notò P. Batiffol in un Auant-Propos premesso alla 7° edizione del volume III (Paris, 1928). L'opera ha raggiunto nel 1930 la sua 11° edizione e non è stata mai del tutto sostituita, nonostante i tentativi di B. J. Otten, A Manual of tbe History of Dogmas, 2 voll., London, 1917, e quello più noto di F. Marin-Sola, L'évolution homogène du dogme catboliquc , 2 voll., Paris, 1924, al quale è stato rimproverato di accentuare molto più l'«omogeneità» che non l'«evoluzione» e di non dare, perciò, il dovuto rilievo all'elemento storico dei dogmi e del loro sviluppo. Il nuovo manuale cattolico di storia dei dogmi, l'Handbuch der Dogmeugeschichte , a cura di M. Schmaus e A. Grillmeier, Herder, 1950 ss. dovrebbe abbracciare in 5 volumi tutta la storia del dogma. Il periodo patristico è trattato in fascicoli rnonografici brevi ma ben informati (usciti già quelli sulla crisrologia di J. Liebaerr, sul battesimo e l'unzione di B. Neunheuser. sulla creazione e la provvidenza di L. Scheffczvk). Di particolare interesse, dal punto di vista di una rifiessione sul senso del dogma e del suo sviluppo storico, è l'ultimo fascicolo: G. Soll, Dogma und Dogmenentuncklung, Freiburg, 1971.
13. Tubingen, 1906; l'opera era apparsa però in prima edizione nel 1902 con il titolo: Von Reimarus zu Wrede. Eine Darstellung der Leben-Jesu-Forscbung. Quello che per il momento esiste come «Storia delle storie dei dogmi» non va molto oltre gli articoli di enciclopedie e le introduzioni, talune ampie e ben informate, premesse alle grandi storie dei dogmi. Si veda]' Auer, Dogmengeschichte, in Lexikon fur Tbeologie und Kircbe, Freiburg, 1959, voI. III, pp. 463-470, e W. Schneemelcher, Das Problem der Dogmengescbichte, in «Zeitschr. f. TheoI. u. Kirche», XLVIII (1951), pp. 63-89.
14. Con questa frase l'autore allude alla problernatica suscitata da W. Bauer, con il suo studio Rechtglaubigkeit und Ketzerei im dltcsten Cbristentum, Tiibingen, 1964 (1°ed. 1934) il quale rovescia la credenza comune secondo cui l'ortodossia precede l'eresia, sostenendo che l'ortodossia è posteriore nel cristianesimo all'eresia e non appare che alla fine del secondo secolo per la forza catalizzatrice della Chiesa di Roma. Le forme primitive di cristianesimo sono più vicine a quelle che in seguito saranno considerate eresie che non a ciò che in seguito si configurerà come ortodossia. La reazione venutasi a creare nei confronti di questa tesi radicale che riduce eresia e ortodossia a pure categorie storiche vuote di contenuto dottrinale, ha portato alla soluzione di H. E. W. Turner, Tbe Pattern 01 the Cbristian Truth, London, 1954, il quale parte proprio dall'analisi della natura profonda dell'ortodossia e della eresia e tenta di chiari me il rapporto studiando l'unità e la diversità, gli «elementi fissi» e gli «elementi flessibili» del cristianesimo primitivo (pp. 26-35), senza tuttavia ritornare alla visione tradizionale, anteriore al Bauer, di una ortodossia dai caratteri unitari e ben definiti, cui si opporrebbe la varietà delle eresie. È significativo che il Kelly definisca la cristologia ebionita e adozionista (il Cristo puro uomo) e la cristologia docetista (il Cristo solo Dio) come «soluzioni unilaterali» («Onesided Solutions») e non « soluzioni eretiche».
15. Un'interessante alternativa a questo criterio di distribuzione è costituito dal piano della Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée di T. Daniélou, di cui sono usciti due volumi: La théologie du [udéo- cbristianisme Paris, 1958 e Message éoangélique et culture bellénistique , Paris, 1961. (Un terzo volume su «Le monde latin» è in preparazione). In tale piano la divisione non è per epoche cronologiche, ma piuttosto per ambienti vitali e culturali in cui il messaggio evangelico si incarna: l'ambiente giudeo-cristiano e l'ambiente ellenistico. La difficoltà tuttavia in questo caso è determinare la vera natura del cosiddetto giudeo cristianesimo.
16. Anche tra gli studi segnalati nella nota bibliografica non c'è che: il libro di O. Cullmann, Cbristus und die Zeit, Zurich, 1962; trad. it., Cristo e il tempo, Bologna, 1965, che contempli questo aspetto per di più quasi esclusivamente limitato alla Scrittura. Un buon complemento, più direttamente attinente all'epoca patristica, può essere dato dalla lettura di J. Daniélou, Le mystère de l'bistoire, Paris, 1953; di C. Andresen, Logos und Nomos, Berlin, 1957, soprattutto pp. 354·372; di A. Luneau, L'bistoire du salut cbez les Pères de l'Eglise , Paris, 1964, e di L. G. Patterson, God and History in Early Cbristian Thought, New York, 1967.
17. Qualcuno (cfr. C. Andresen, in «Theologische Litcraturzcitung», cit., p. 598) ha creduto di scorgere nelle scelte bibliografiche dell'autore una prevalenza della produzione francese su quella tedesca, deducendone implicitamente una certa valutazione circa la collocazione teologica dell'opera. Ma mi pare a torto. Semmai si deve notare come il Kelly abbia saputo trar profitto dalla vastissima e talora eccellente produzione della Chiesa anglicana, specie nel settore che riguarda la dottrina trinitaria e la cristologia (evidente soprattutto l'influsso di G. Prestige, God in Patristic Tbougbt, London, 1936; trad. it., Dio nel pensiero dei Padri, Bologna, 1969), produzione, a mio parere, non sempre valorizzata come merita nel continente.
18. Cfr. D. Nineham, in «Journa! of Ecclesiastica! History», X (1959) p. 93.
19. Cfr. A. Grillmeier, in «Theologische Revue», LVII (1961), col. 116.
20. Tixeront, op. cit., voI. I, pp. 62-118. Il titolo che l'autore dà a questo capitolo è significativo: Le premier état du dogme cbrétien: la prédication de Jésus et des Apàtres. Anche il manuale di Schmaus e Grillmeier comporta all'inizio di ogni trattato una introduzione biblica: vedi per es. quella sulla cristologia curata da P. Lamarche.
21. Cfr. per es. R. H. Fuller, Tbe Foundations 01 New Testament Cbristology ; London, 1965, pp. 242 ss., e anche F. Hahn, Christologiscbe Hobeitstitel. lbre Gescbicbte im [rùben Cbristentum, Gottingen, 1964
22. La tendenza a non assolutizzare troppo il limite che separa la letteratura canonica del Nuovo Testamento da quella sub-apostolica si nota anche negli scritti del Cullmann; ma l'esempio più significativo si ha nel Kvrios Cbristos di W. Bousset (Gortingen, 1913), che fa terminare con Ireneo la sua ricostruzione della cristologia biblica.
23. È questo forse il vantaggio maggiore che il manuale di storia dei dogmi o, in genere, una storia globale del pensiero cristiano antico come questa del Kelly presenta rispetto alle trattazioni monografiche delle singole dottrine come quella di J, Lebreton relativa alla Trinità, quella di A. Grillmeier sulla cristologia (Cbrist in Cbristian Tradition, London, 1965), di J, Rivièrc. sulla redenzione, di H. Rondet sulla grazia, ecc. Queste rnonografie che in campo cattolico sono state coltivate a preferenza dei manuali di storia dei dogmi, hanno, in compenso, il vantaggio di mettere in miglior rilievo la continuità verticale, vale a dire lo svilupp «cronologico della riflessione all'interno di una singola dottrina, non dovendo ricorrere ai «tagli» in sezioni più o meno estese necessari nelle trattazioni generali,
24. W. Miinscher, Handbuch der christlicben Dogmengeschicbte, Marburg, 1797, vol. I, pp. 3-4.
25. È nota la controversia sul modo di concepire la storia della letteratura dei primi secoli che oppose Bardenhewer ad Harnack e che si esprime nel diverso aggettivo usato per tale letteratura: «cristiana» per Harnack, «ecclesiastica» per il cattolico Bardenhewer. Se sul piano letterario la visione di Harnack appare più giustificata di quella del suo avversario, la cosa è diversa, evidentemente, quando si tratta della storia delle dottrine, perché in questo caso l'autorità di chi le rappresenta non è un elemento accidentale.
26. Mi riferisco soprattutto alla ricostruzione dell'origine della dottrina trinitaria messa in luce da G. Kretschmar nel suo noto libro: Studien zur frùbcbristlichen Trinitatstbeologie, Tiibingen, 1956,. in cui fa risalire l'inizio della teologia trinitaria all'angelologia giudaica rielaborata nella liturgia cristiana primitiva. Daniélou ha dimostrato che Krerschmar ha colto un aspetto reale della teologia trinitaria primitiva, un aspetto tuttavia, che non è proprio di tutta la teologia cristiana, ma solo di quella del giudeo-cristianesimo: cfr. La théologie du Judéochristianisme, cit., pp. 167-198.
INDICE DEL VOLUME
Introduzione all'edizione italiana, di Raniero Cantalamessa
Prefazione alla prima edizione
Prefazione alla seconda edizione
PARTE PRIMA: PROLEGO
I. L'ambiente
1.L'epoca patristica
2.Gli orientamenti religiosi nell'impero romano
3.La filosofia greco-romana
4.Il neoplaronismo
5.Il giudaisrno
6.La via gnostica
II. Tradizione e Scrittura
1.La norma della dottrina
2.Il periodo primi rivo
3.Irenco c Tcrrulliar:o
4.Il terzo e quarto secolo
5.L'appello ai Padri
III. Le Sacre Scritture
1.L'Antico Testamento
2.Il canone neotestamentario
3.L'ispirazione della Scrittura
4.L'unità dei due Testamenti
5.Tipologia e allegoria
6. La reazione antiochena
PARTE SECONDA: LA TEOLOGIA PRENICENA
IV. La Triade divina
1.Un solo Dio creatore
2.La fede della Chiesa
3.I Padri Apostolici
4.Gli Apologisti e il Verbo
5.Gli Apologisti e la Trinità
6.Ireneo
V. Il trinitarismo del terzo secolo
1.Introduzione
2.Ippolito e Tertulliano
3.Il monarchianismo dinamico
4.Il monarchianismo modalistico
5.La teologia romana
6.Clemente e Origene
7.L'influenza di Origene
VI. Gli inizi della cristologia
1.Soluzioni unilaterali'
2.La cristologia pneumatica
3.Gli Apologisti e Ireneo
4.Il contributo occidentale
5.La scuola di Alessandria
6.L'oriente dopo Origene
VII. L'uomo e la sua redenzione
1.L'epoca sub-apostolica
2.Gli Apologisti
3.La teoria della ricapitolazione
4.L'occidente nel terzo secolo
5.La dottrina dell'uomo in oriente
6.Le opinioni orientali sull'opera di Cristo
VIII. La comunità cristiana
1.Gli inizi dell'ecclesiologia
2.Le antiche concezioni sui sacramenti
3.Gli sviluppi della dottrina della Chiesa
4.Il battesimo nel terzo secolo
5.Lo sviluppo della dottrina eucaristica
6.La disciplina penitenziale
PARTE TERZA: DA NlCEA A CALCEDONIA
IX. La crisi nicena
1.La vigilia del conflitto
2.L'insegnamento di Ario
3.La teologia di Nicea
4.Le conseguenze di Nicea
5.Il partito niceno e Atanasio
6.Gli antiniceni
X. La dottrina della Trinità
1.Il ritorno all'«homoousion»
2.L'«homoousion» dello Spirito: Atanasio
3.L'«homoousion» dello Spirito: i Cappadoci
4.I Cappadoci e la Trinità
5.La Trinità in occidente
6.Il contributo di Agostino
XI. La cristologia nel quarto secolo
1.Introduzione
2.Gli ariani ed Eustazio
3.La cristologia di Atanasio
4.L'eresia di Apollinare
5.La reazione ortodossa
6.La cristologia antiochena
XII. L'accordo cristologico
1.Il nestorianesimo
2.Cirillo di Alessandria
3.Da Efeso all'unità
4.La controversia di Eutiche
5.L'occidente e Leone
6.L'accordo di Calcedonia
XIII. L'uomo caduto e la grazia di Dio
1.L'origine dell'anima
2.Atanasio e la caduta
3.I Padri greci
4.L'occidente prima di Agostino
5.La dottrina di Pelagio
6.Agostino e il peccato originale
7.Grazia e predestinazione
8.Lo sviluppo dottrinale in occidente
9.L'oriente nel quinto secolo
XIV. L'opera di salvezza di Cristo
1.La chiave della soteriologia
2.Atanasio
3.I Padri greci del quarto secolo
4.L'occidente nel quarto secolo
5.Agostino
6.L'oriente nel quinto secolo
XV. Il corpo mistico di Cristo
1.L'ecclesiologia in oriente
2.L'oriente e la sede romana
3.Dottrine occidentali: llario e Optato
4.Dottrine occidentali: Agostino
5.L'occidente e il primato romano
XVI. Sviluppi della dottrina dei sacramenti
1.Teoria generale
2.Il battesimo
3.Confermazione o cresima
4.La penitenza
5.La presenza eucaristica
6.Il sacrificio eucaristico
PARTE QUARTA: EPILOGO
XVII. La speranza cristiana
1.La tensione nella escatologia
2.Le concezioni escatologiche del secondo secolo
3.Lo sviluppo del dogma
4.Origene
5.La risurrezione dei corpi nel pensiero posteriore
6.Parusia e giudizio nel pensiero posteriore
7.La vita eterna
Indice dei nomi