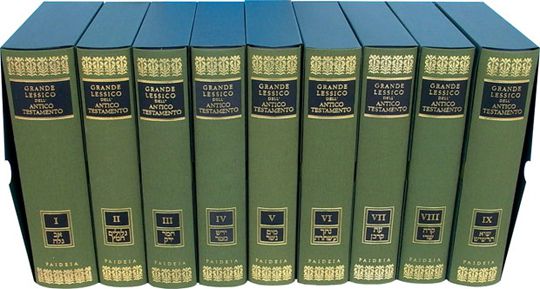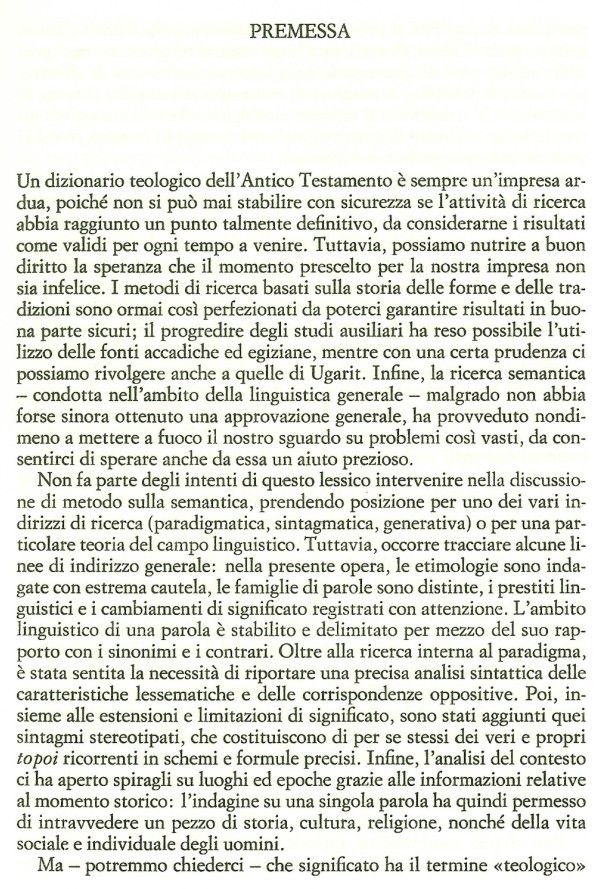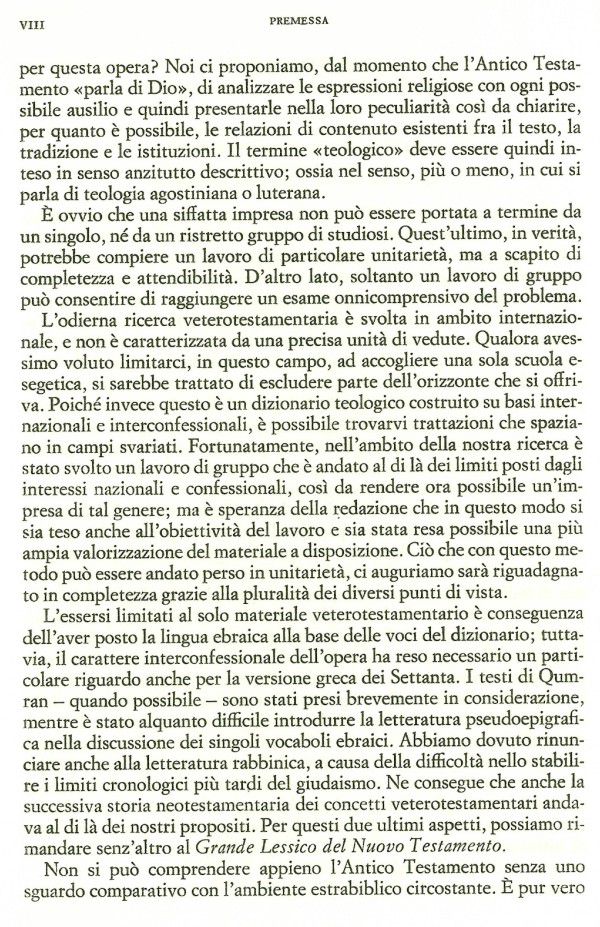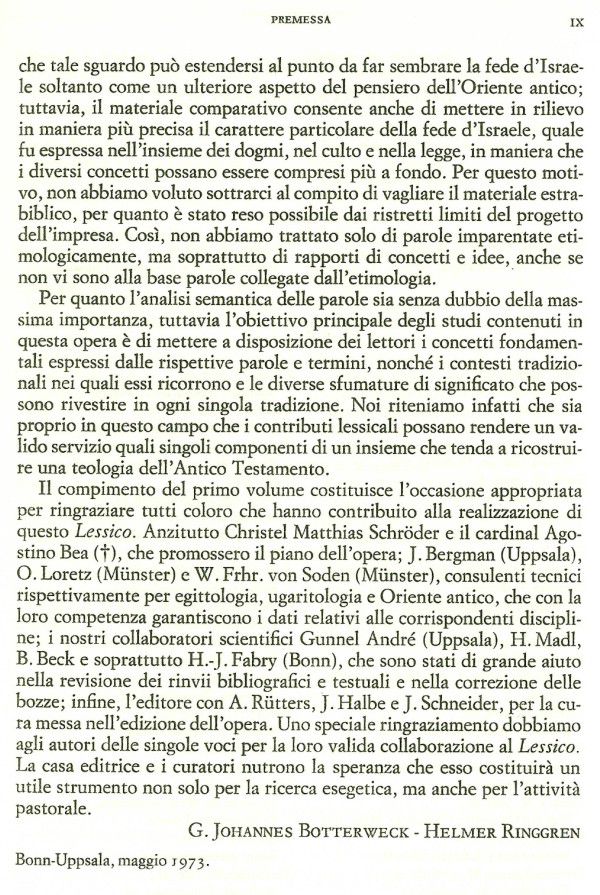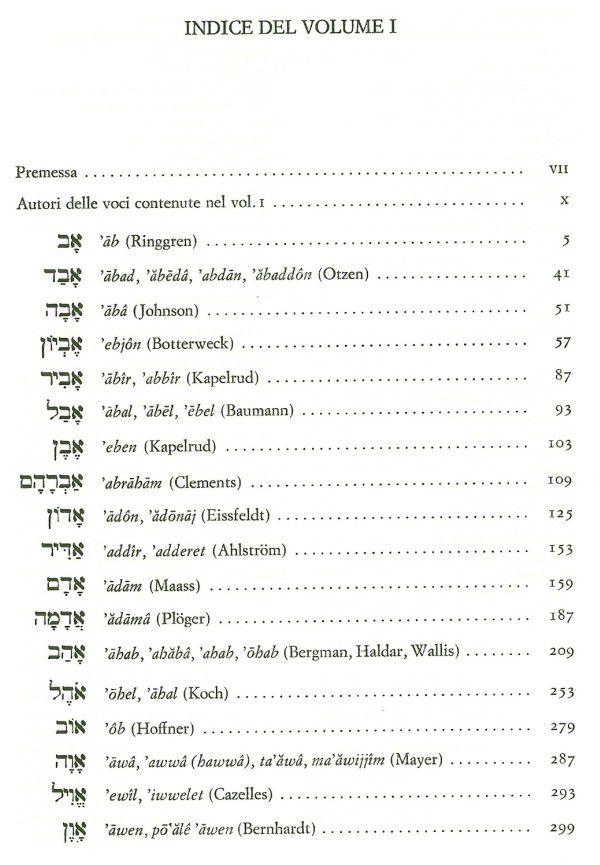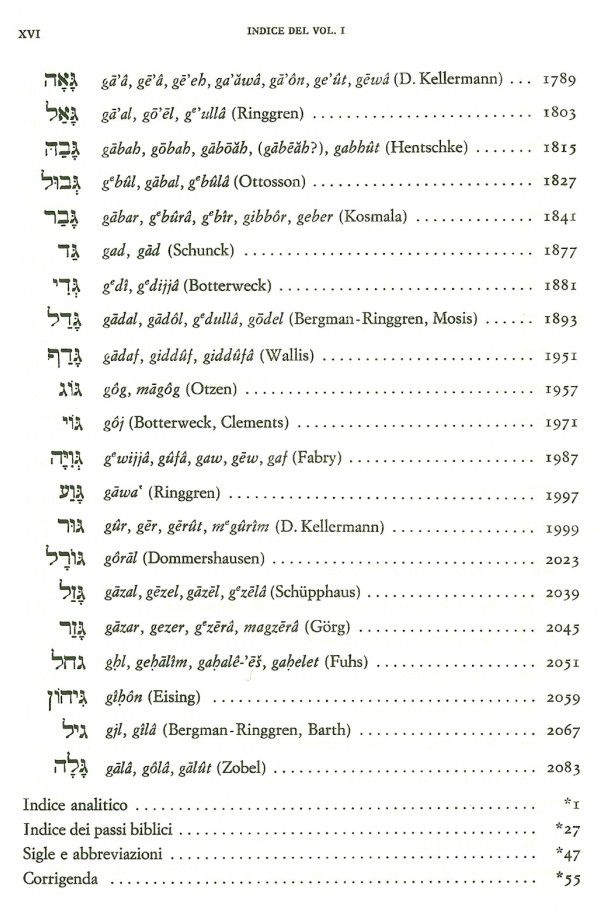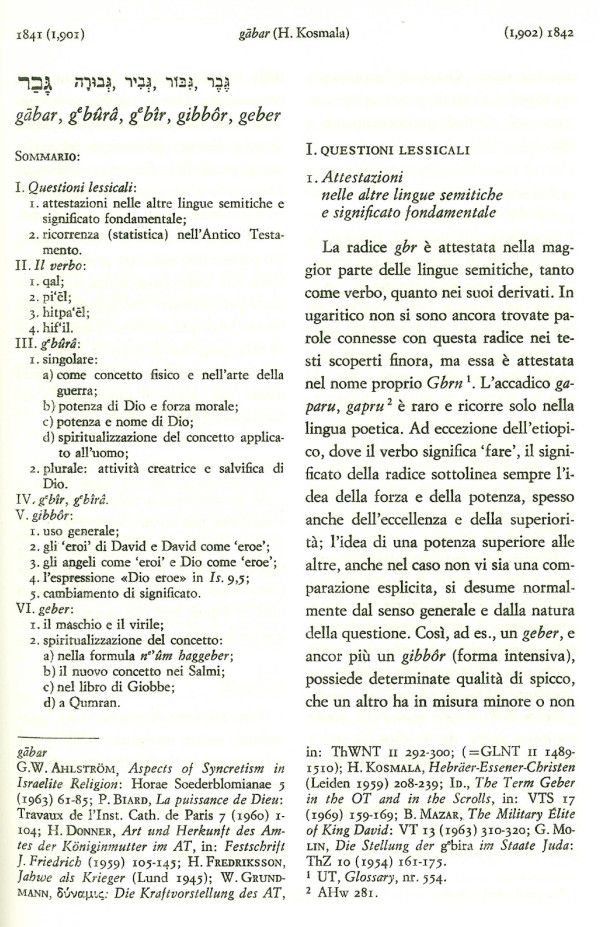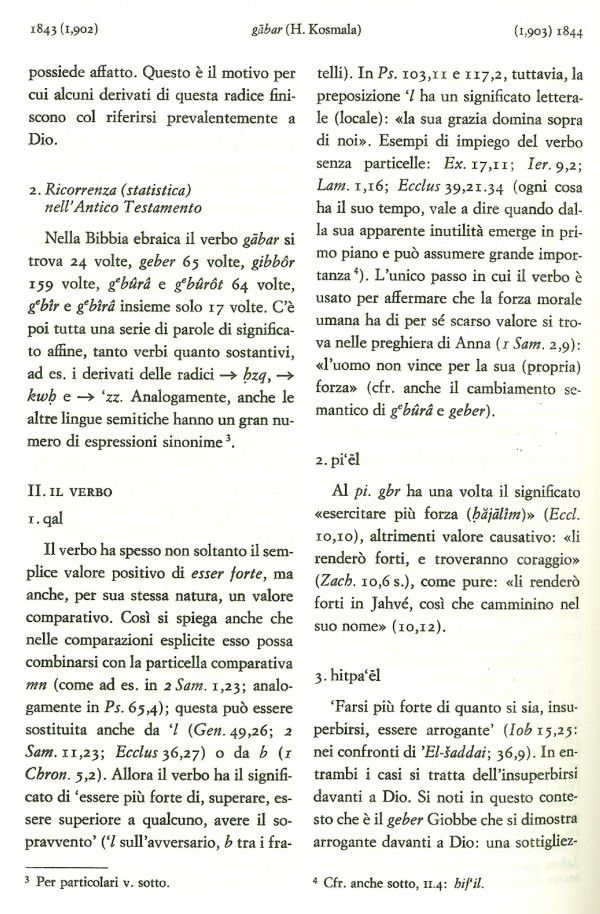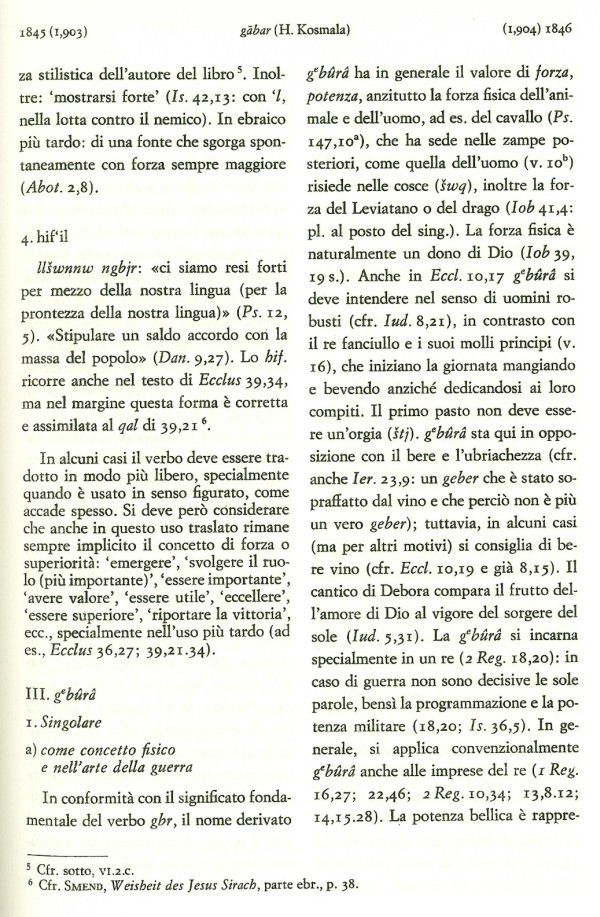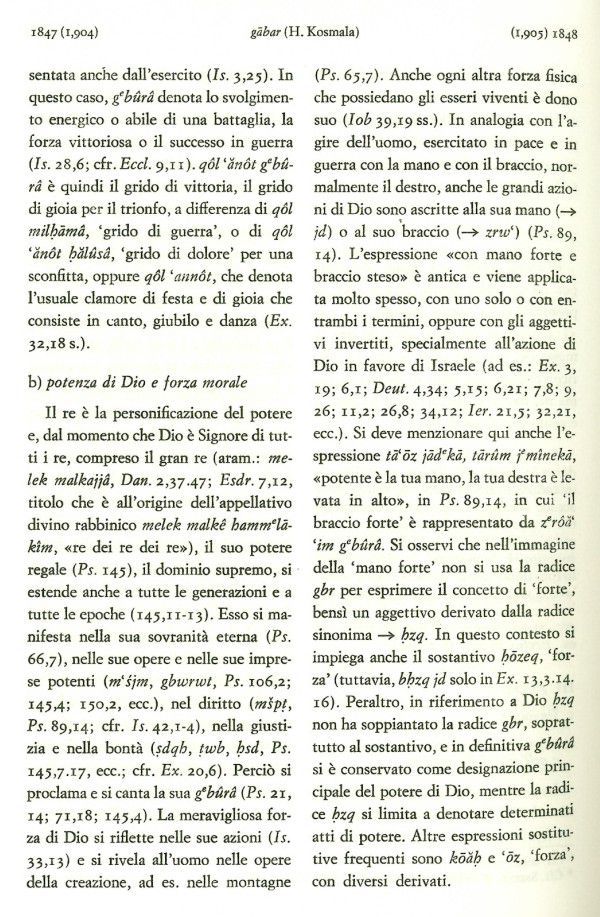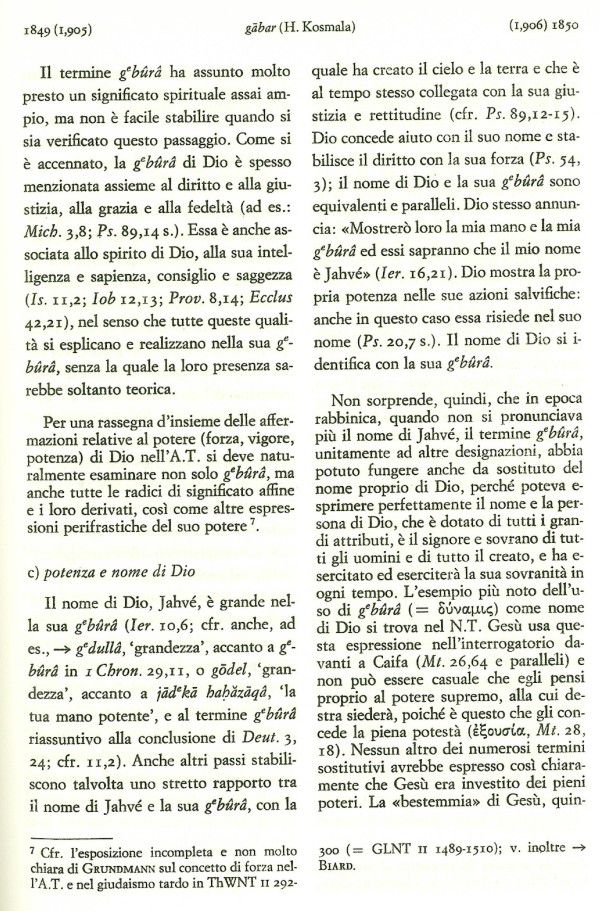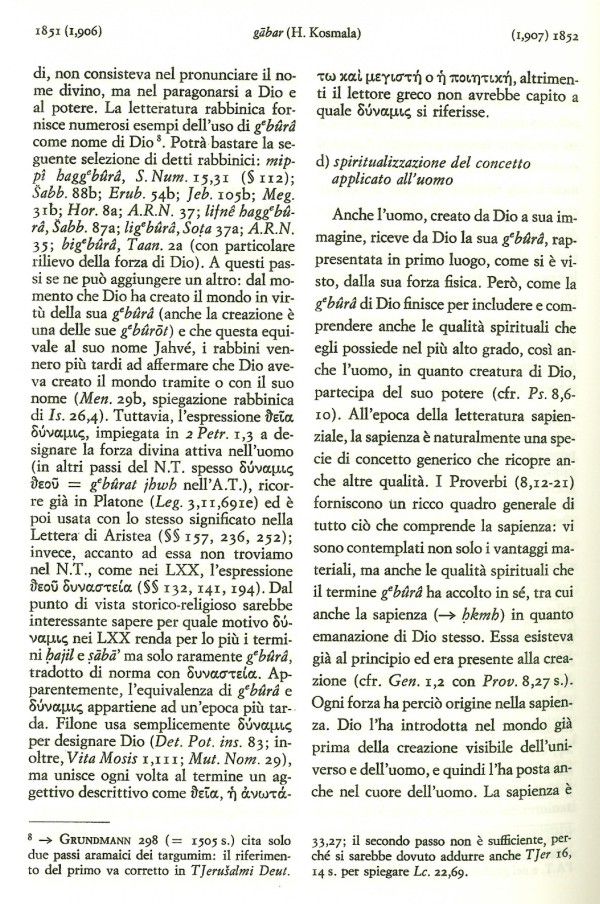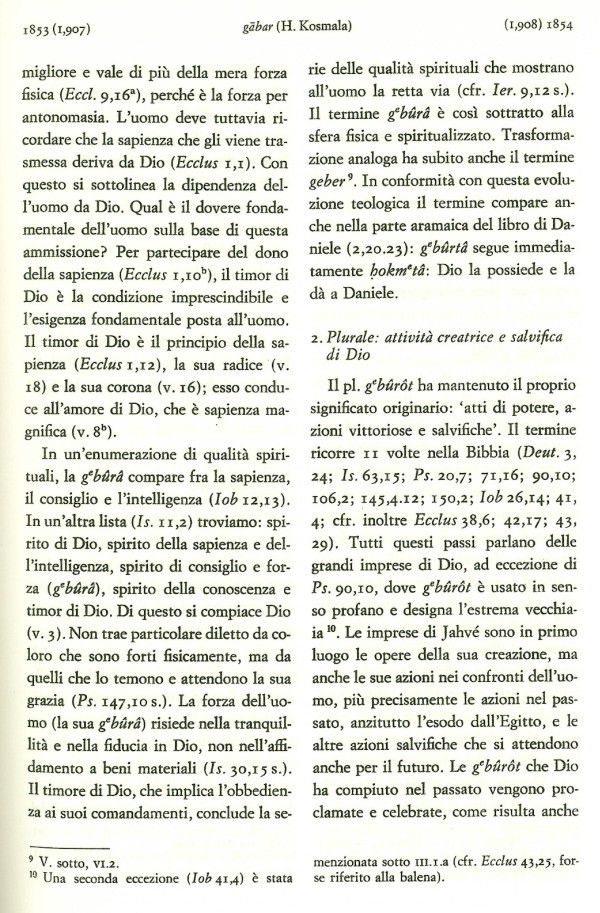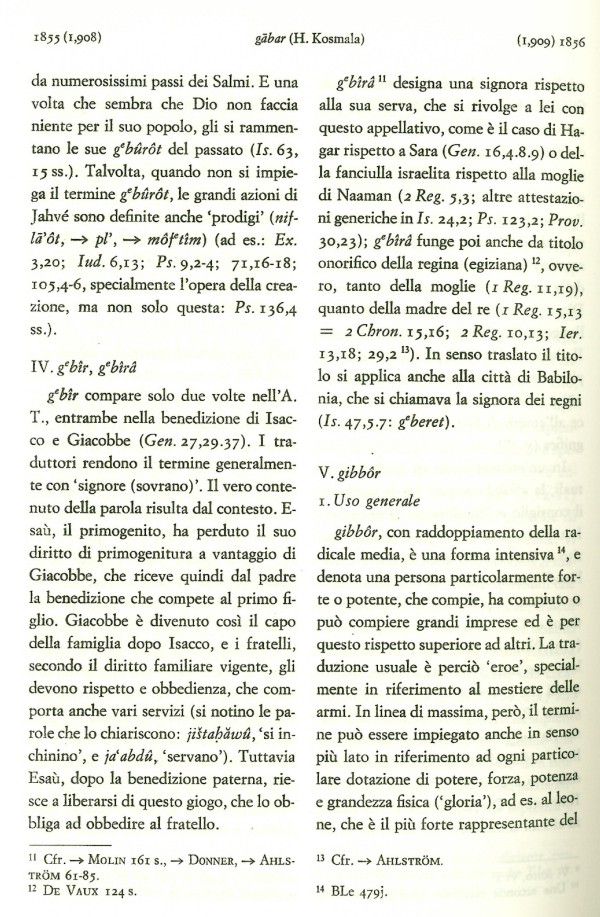IL CANONE DELLE SCRITTURE
RETROCOPERTINA
In che modo i libri della Bibbia sono stati riconosciuti come documenti della rivelazione divina? Chi a ha deciso quale struttura il canone dovesse avere? Quali criteri influenzarono tali decisioni?
Dopo circa diciannove secoli il canone della Scrittura rimane un argomento dibattuto. Protestanti, cattolici, e ortodossi hanno collezioni di testi che divergono tra loro seppur di poco. Lutero, una delle figure preminenti della Riforma, avanzò dei dubbi sull'inclusione della Lettura di Giacomo e nel corso degli anni gli studiosi hanno poi sollevato numerose altre questioni riguardanti il canone. Molti cristiani oggi, mentre confessano l'autorità di tutte le scritture, sembrano fare affidamento solo su pochi libri e temi particolari ignorando completamente il resto.
In questo significativo studio, Bruce, grazie alla conoscenza derivatagli da anni di riflessione e interpretazione biblica, risponde a queste domande e dissipa la confusione che circonda il canone delle Scritture.
Sebbene molte cose siano cambiate dalla sua prima pubblicazione, questo libro rimane una pietra miliare nella critica biblica.
Il canone delle Scritture è stato premiato nel 1990 con due Christianity Today Awards e nel 1989 con L'ECPA Christian Book Award.
PREFAZIONE
Durante i miei anni di insegnamento all'Università di Manchester ho tenuto, ad anni alterni, lezioni sul testo e sul canone dell' Antico e del Nuovo Testamento. Le mie lezioni riguardanti il testo, spero; abbiano risposto ai bisogni degli studenti che frequentarono quei corsi ma non richiedono ulteriori pubblicazioni. L'argomento del canone biblico, invece, continua a vedermi impegnato, sia per ciò che concerne l'aspetto storico sia per quel che riguarda la sua rilevanza oggi.
Sarà chiaro, da quanto seguirà, il mio maggior coinvolgimento nello studio del canone neotestamentario rispetto a quello veterotestamentario. Il collasso del secolare consenso sul canone dell'Antico Testamento - vale a dire, sul processo di canonizzazione indicato dalla triplice divisione dei libri nella Bibbia ebraica - è stato sottolineato in due importanti opere di recente pubblicazione: The Old Testament Canon of the New Testament Church di Roger Beckwitt e Oracles of God di John Barton. Sono stati fatti degli attacchi anche al canone del Nuovo Testamento, cioè quello la cui struttura principale venne sostanzialmente fissata dalla fine del secondo secolo. Tuttavia, esso continua a rimanere valido perché supportato da pesanti evidenze, come mostrato nell' ottimo lavoro di Metzger, The Canon of the New Testament. Quando, però, il consenso generale subisce degli attacchi è necessario riesaminare attentamente la questione e ciò è sempre positivo: non ha senso fingere di sapere più di quanto sappiamo in realtà.
Considerando le opere appena citate ci si potrebbe chiedere: «Perché scrivere un altro libro sull' argomento?». Probabilmente perché 1'autore sentiva il bisogno di dire la propria o piuttosto, si potrebbe giustificare la pubblicazione come un tentativo di comunicare lo stato attuale degli studi a un pubblico più ampio.
Sono molto grato all'Università di Londra e alla Epworth Review per avermi concesso di inserire come appendici i miei interventi in occasione della conferenza Ethel M. Wood (1974) e di quella tenuta per il memoriale del prof. Peake (1976).
Fu il mio stimato insegnante, Alexander Souter, professore emerito di Discipline Umanistiche dell'Università di Aberdeen, ad introdurmi per primo a questo argomento attraverso la prima edizione di The Text and the Canon of the New Testament. Il mio debito nei suoi confronti, verso il Dipartimento da lui presieduto egregiamente e il Dipartimento di Greco, è riconosciuto nella mia dedica.
F. F. Bruce
INTRODUZIONE
1. Le Sacre Scritture
La parola «canone»
Quando parliamo di canone della Scrittura, la parola «canone» ha un significato semplice. Essa indica l'elenco dei libri contenuti nella Scrittura, dichiarati degni di essere inclusi nei sacri testi di una comunità di adorazione. Nel contesto cristiano, possiamo definire la parola come «la lista dei testi riconosciuti dalla Chiesa come documenti della rivelazione divina».1 La parola appare essere usata in questo senso per la prima volta da Atanasio, vescovo di Alessandria, in una lettera messa in circolazione nell'anno 367 d.C.2
Il termine «canone» è giunto nel nostro linguaggio (attraverso il latino) dalla parola greca kanon3 In greco significa bastone, in special modo un bastone usato come metro; da questo uso proviene 1'altro significato che la parola porta comunemente con sé: «metro», «modello». Si parla, per esempio, del canone o delle leggi della Costituzione italiana. Un bastone diritto usato come un metro può avere dei segni di unità di misura (come una moderna riga che è divisa in centimetri o in pollici); da questa pratica la parola greca ha cominciato a essere usata per indicare il susseguirsi di questi segni, e quindi a essere utilizzata nel significato generico di «serie» o «lista». È quest'ultimo uso della parola che soggiace all'espressione «canone della Scrittura».
Prima che la parola «canone» venisse usata nel significato di «lista», fu impiegata in un' altra accezione dalla chiesa: nell'espressione «regola di fede» o «regola di verità».4 Nei primi secoli dell'era cristiana ciò indicava il sommario dell'insegnamento cristiano, ovvero ciò che si credeva riproducesse l'insegnamento stesso degli apostoli, per mezzo del quale ogni sistema dottrinale sottoposto all' accoglienza dei cristiani, o qualunque interpretazione degli scritti biblici, doveva essere valutato. Ma, una volta che i limiti della Sacra Scrittura cominciarono a essere in genere convenuti, la Sacra Scrittura stessa venne considerata come la regola di fede. Per esempio, Tommaso d'Aquino (1225-1274) disse che: «La scrittura canonica soltanto è la regola di fede». Da un'altra prospettiva teologica la Confessione di Fede di Westminster (1647), dopo aver elencato i sessantasei libri dell' Antico e del Nuovo Testamento, aggiunge: «I quali tutti sono dati per ispirazione da Dio, per essere la regola della fede e della vita».5 Queste parole affermano lo stato della Sacra Scrittura come «canone» o «modello» attraverso il quale devono essere regolati l'insegnamento e la prassi cristiana. Mentre il «canone» biblico significa la lista dei libri accettati come Sacra Scrittura, l'altro senso della parola «canone» - metro o modello - è stato inglobato in quest'ultimo, cosicché il «canone» della Scrittura è inteso essere la lista dei libri riconosciuti, in un senso unico, quali metro di misura del credo e della prassi.
La domanda da esaminare nelle pagine seguenti è: come hanno potuto certi documenti, e soltanto questi, ricevere un tale riconoscimento? Chi, se mai qualcuno, ha deciso che questi, e non altri, dovessero essere ammessi nella lista dei libri della Sacra Scrittura, e, quali furono i criteri che influenzarono questa decisione?
Il popolo del libro
Molte religioni hanno dei testi sacri associati sia alle loro tradizioni sia alloro culto. Celebre in passato la serie di volumi intitolata The Sacred Books of the East [I testi sacri orientali].6 Tuttavia i giudei, i cristiani e i musulmani sono conosciuti come «popoli del libro» in un senso speciale. Questa è una designazione data nel corano, più e più volte agli ebrei e ai cristiani. Tra i «popoli del libro», il testo sacro ha una funzione regolatrice: la conformità a ciò che il libro prescrive è un'importante prova della lealtà alla loro fede e pratica religiosa.
Per gli ebrei il «libro» è la Bibbia ebraica, comprendente la Legge, i Profeti e gli Scritti (dalle iniziali di queste tre sezioni nella Bibbia ebraica spesso tra i giudei ci si riferisce ad essa come alla TeNaKh).7 Per i cristiani è la Bibbia ebraica, che essi chiamano Antico Testamento (ampliato un po' in certe tradizioni cristiane),8 insieme al Nuovo Testamento. I musulmani riconoscono la Bibbia ebraica, la tawrat (termine arabo equivalente all'ebraico toriih, «legge»), e il Nuovo Testamento cristiano, lo injrl (dal greco euangelion, «vangelo»), come rivelazioni antiche di Dio, ma queste trovano il loro completamento nella rivelazione data attraverso il profeta, il Qur' an (letteralmente «narrazione» o «lettura»), il "libro" per eccellenza.
I due Testamenti
Il nostro interesse qui è rivolto alla Bibbia cristiana, comprendente 1'Antico e il Nuovo Testamento. In italiano la parola «testamento» generalmente denota un volere (ede ultime volontà o il testamento» di qualcuno); ma questo non è il significato con cui è impiegata per le due parti della Bibbia cristiana. La nostra parola «testamento» deriva dal latino testamentum, che similmente significa un volere, ma in questo particolare contesto il termine latino è usato come traduzione della parola greca diatheke. Quest'ultima può sì significare una volontà espressa.9 ma è usata in maniera più ampia per indicare vari tipi di accomodamento o di accordo, non tanto uno stipulato tra eguali quanto un accordo in cui una parte, superiore in potere o in dignità, conferisce certi privilegi a una parte inferiore, mentre la parte inferiore si fa carico di certi obblighi nei confronti della parte superiore. li termine ricorre nell'Antico e nel Nuovo Testamento, sia nella traduzione in greco della Bibbia ebraica sia nel greco originale del Nuovo Testamento. È solitamente reso dalla nostra parola «patto», e il suo uso più distintivo fa riferimento a un patto tra Dio e gli esseri umani. In questo caso, ovviamente, non c'è possibilità di un accordo tra eguali.
Nei più antichi libri dell'Antico Testamento Dio fa un patto con Noè e con i suoi discendenti (Gen 9:8-17), e nuovamente con Abraamo e i suoi discendenti (Gen 15:18, 17:1-4). li segno esteriore del patto con Noè fu l'arcobaleno; il segno esteriore del patto con Abraamo fu il rito della circoncisione.
In seguito, quando i discendenti di Abraamo (o perlomeno un gruppo importante fra loro) migrarono in Egitto e quivi furono costretti alla schiavitù, Dio si ricordò del patto stipulato con Abraamo e portò a compimento la loro liberazione. Dopo aver lasciato l'Egitto sotto la guida di Mosè, furono costituiti come nazione nel deserto del Sinai. La loro costituzione nazionale prese la forma di un patto che il Dio dei loro padri stipulò con loro, facendosi conoscere con il nome di YHWH.10 I termini di questo patto erano, molto semplicemente: «lo sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo». YHWH si impegnò a prendersi cura di loro in diversi modi; essi si impegnarono ad adorare lui soltanto e a ubbidire ai suoi comandamenti. Questi obblighi furono registrati in un documento chiamato «il libro del patto». Secondo la narrazione di Esodo 24:4-8:
Mosè scrisse tutte le parole del SIGNORE. Poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e dodici pietre per le dodici tribù d'Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al SIGNORE. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini; l'altra metà la sparse sull' altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto e ubbidiremo». Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che il SIGNORE ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole».
Questa narrazione è riassunta nel Nuovo Testamento, in Ebrei 9:18-20, dove il patto così ratificato è qualificato come «il primo patto». Questo perché l'autore di Ebrei lo pone in contrasto con il «nuovo patto» promesso in Geremia 31 :31- 34. A seicento anni di distanza dal patto stipulato con Mosè ai piedi del monte Sinai, il profeta Geremia annunciò che, nei giorni a venire, il Dio di Israele avrebbe stabilito un nuovo patto con il suo popolo per rimpiazzare quello che egli fece con la generazione dell' esodo quando li prese «per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto» (Ger 31 :31- 34). Quel patto antico metteva loro in chiaro il volere divino, ma non impartiva la forza per adempierlo. Sotto il nuovo patto, invece, non solo il desiderio, ma anche la forza per compiere il volere di Dio sarebbe stata dispensata al suo popolo: la sua legge sarebbe stata posta nel loro intimo e scritta sui loro cuori. «Dicendo un nuovo patto» scrive l'autore di Ebrei, «egli ha dichiarato antico il primo» (Eb 8: 13). Ed egli non lascia i suoi lettori nel dubbio: il nuovo patto è già stato stabilito, ratificato non dal sangue di animali sacrificali ma dal sangue di Cristo, un sacrificio i cui effetti non consistono soltanto in una purificazione esteriore dalla contaminazione rituale, ma piuttosto nella purificazione interiore della coscienza dalla colpa.
Questa interpretazione della promessa del nuovo patto è pienamente in linea con le parole stesse di Gesù. Nella sera precedente la sua morte, mentre sedeva con i suoi discepoli intorno alla tavola della cena, egli diede loro il pane e il vino come memoriali di se stesso. Quando diede loro il vino, secondo quanto riportato da Marco, egli disse: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, che è sparso per molti» (Mc 14:24). Difficile non notare l'eco delle parole di Mosè: «Ecco il sangue del patto ...». È sottointeso che il patto associato al sangue di Gesù O' offerta volontaria di se stesso) coincida con il nuovo patto di cui parla Geremia; l'implicazione è esplicita nelle parole di Paolo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue» (1 Cor 11 :25).11
Ognuno di questi patti - quello antico del Sinai e il nuovo inaugurato da Gesù - diedero il via a un grande movimento spirituale. Ognuno di essi fece fiorire uno speciale corpus letterario, i quali furono poi conosciuti nella chiesa cristiana come «il libro dell'antico patto» e «il libro del nuovo patto». La prima raccolta venne all'esistenza in un periodo di mille anni o oltre; la seconda ha un carattere più inaugurale. Le sue varie parti furono composte entro un secolo dalla ratificazione del nuovo patto; essi possono essere considerati come i documenti fondanti della cristianità. Fu solo alla fine del II secolo d.C. che le due collezioni cominciarono a essere descritte come l'Antico Patto (o Testamento) e il Nuovo Patto (o Testamento). Questi titoli furono attestati quasi contemporaneamente sia in greco sia in latino: in greco, nelle opere di Clemente d'Alessandria,12 in latino, nell' opera di Tertulliano di Cartagine.13
È stato suggerito che l'espressione «il Nuovo Patto (o Testamento)» fu usata per prima per denotare una raccolta di libri nell'anno 192 d.C., in un'opera antimontanista in greco composta da un autore ignoto, indirizzata al vescovo della Frigia Avircio14 Marcello, da cui Eusebio cita alcuni passi. Quest' opera parla della «... parola del Nuovo Testamento evangelico, alla quale chi ha scelto di vivere secondo il Vangelo non può aggiungere o togliere niente».15 È improbabile, tuttavia, che questo sia un riferimento al Nuovo Testamento nel senso odierno del termine;16 l'anonimo autore è un pò disturbato dalla possibilità che il suo stesso lavoro possa essere visto come un'aggiunta alla «parola del Nuovo Testamento evangelico».
Un canone chiuso
Le parole «alla quale ... non può aggiungere o togliere niente», qualunque cosa possano significare in questo contesto, sembrano certamente implicare il principio di un canone chiuso. Secondo alcuni studiosi la parola «canone» dovrebbe essere usata soltanto là dove la lista dei libri dotati di speciale autorità sia da ritenersi chiusa; e c'è molto da dire ancora in favore di questo uso restrittivo della parola (una parola più flessibile potrebbe essere usata per la collezione durante la fase di formazione), benché potrebbe essere pedante insistere su essa in modo invariabile.
Un tale linguaggio circa il non aggiungere e il non togliere nulla è usato in relazione a singoli componenti dei due Testamenti. Alla legge che si trova in Deuteronomio è legato l'avvertimento: «Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla» (Dt 4:2; cfr. 12:32). Un più ampio avvertimento è apposto al Nuovo Testamento: «lo lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro; se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall' albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro» (Ap 22:18-19).17
L'autore della Didacbè (un antico manuale di disciplina della chiesa) fa eco al monito di Deuteronomio quando dice: «Non abbandonerai i precetti del Signore, ma conserverai ciò che hai ricevuto, "senza aggiungere o togliere nulla?».18 Circa nello stesso periodo (fine del primo secolo d.C.) Giuseppe Flavio usa un linguaggio simile a proposito delle scritture ebraiche: «Pur essendo trascorso tanto tempo, nessuno ha osato aggiungere, togliere o modifìcare alcunché».19 Questo linguaggio difficilmente può voler significare altro se non un canone chiuso.20
Riconoscimento liturgico
Lo status delle Scritture è simbolicamente riconosciuto in varie tradizioni di liturgia pubblica. Una speciale venerazione è resa ai rotoli della legge durante il servizio in sinagoga mentre sono trasportati dalla sacra arca, dove sono custoditi, alla bimah, da dove sono letti alla congregazione. Nella liturgia della chiesa ortodossa il libro dell'angelo è portato in processione, e la sua lettura è preceduta dall'appello: «Sapienza! Tutti in piedi; ascoltiamo il vangelo». La venerazione così resa al libro del vangelo non è resa ai materiali di cui è fatto, ma alla Santa Sapienza che trova espressione nelle parole che vengono lette. Nella liturgia cattolica il vangelo è trattato con una simile venerazione e la lettura da esso è preceduta e seguita da preghiere speciali. Nel servizio di comunione della chiesa anglicana le persone si alzano mentre il vangelo viene letto, e quando viene annunciato essi solitamente dicono: «Gloria a Cristo nostro Salvatore», mentre alla conclusione della lettura, quando il lettore dice: «Questo è il Vangelo di Cristo», essi rispondono: «Lode a Cristo nostro Signore».
In chiese di tipo riformato (come la chiesa di Scozia e altre chiese presbiteriane in tutto il mondo) il primo atto formale in un servizio liturgico pubblico avviene quando la Bibbia dalla sagrestia viene portata nella sala e posta sul pulpito. Qualcuno, certamente, è incaricato di portarla (il sagrestano, forse, o «il funzionario di Chiesa»), ma tale persona non ha un'importanza liturgica (anche se, nei primi tempi, qualcuno pensò di «esaltare la propria funzione»); è la Bibbia che riveste un significato liturgico. La Bibbia è seguita a debita distanza dal ministro. Perché? Perché egli è il ministro - cioè, nel senso originale del termine, il «servitore» della Parola. Nessuna sigla indicante conseguimenti accademici o pubblico onore può eguagliare la dignità della sigla V. D. M., posta di seguito al nome del pastore in qualche chiesa riformata - « Verbi Divini Minister», «servitore della Parola di Dio». Quando durante il servizio viene il tempo della lettura pubblica della Bibbia, questo aspetto è sottolineato dall'esortazione introduttoria: «Ascoltiamo la Parola di Dio».
È dal contenuto, dal messaggio, del libro che ne deriva il suo valore, sia che pensiamo al Vangelo in particolare sia che pensiamo alla Bibbia nella sua totalità. È dunque importante conoscere quelli che sono i suoi contenuti, e come essi sono venuti ad essere distinti da altri scritti - anche se scritti sacri o ispirati. Questo è lo scopo dell' esaminare lo sviluppo del canone della Sacra Scrittura.
NOTE
1. R.P.C. Hanson, Origen's Doctrine of Tradition, Hanson Publisher, Londra, 1954, pp. 93, 133; cfr. il suo Tradition in the Early Church, Hanson Publisher, Londra, 1962, p. 247.
2. Cfr. pp. 65, 72, 73, 216 e seguenti.
3. Il termine greco probabilmente è stato preso in prestito da una parola di origine semitica che in ebraico figura come qaneb, «canna», «bastone». Probabilmente la stessa origine del termine latino canna.
4. Vedi pp. 152, 184.
5. Tommaso d'Aquino, Commento al Vangelo di San Giovanni, voll. 3, Città Nuova, Roma, 1992, p. 409ss., lezione 6 su Giovanni 21 (sola canonica scriptura est regula fidei, forse « ... una regola di fede»); Confessione di Fede di Westminster, 1.2.
6. I 55 volumi, in origine a cura di Friedrich Max Miiller, apparvero tra il 1879 e il 1924 (Oxford: Clarendon Press).
7. Questa parola è un acronimo, formato dalle lettere iniziali della Torah («legge», «istruzione»), N bi'im («profeti») e K tubim («scritti»), i nomi dati alle tre divisioni, (vd. p. 16).
8. Vd. pp. 37ss.
9. Vd. p. 186.
10. Vd. Es 3:7-l5.
11. Quella di Paolo è la più antica testimonianza scritta delle parole che Gesù pronunciò durante l'ultima cena (55 d.C.): essa riporta esattamente quanto appreso dall'apostolo dopo la sua conversione. Il resoconto di Marco (scritto all'incirca nel 65 d.C.) riporta le parole così come furono tramandate da un'altra linea di trasmissione.
12. Vd. p. 194.
13. Vd. p. 185.
14. Scritto anche Abercio (gr. Aberkios).
15. Eusebio, h.e. 5.16.3, trad. it. a cura di S. Borzì e F. Migliore, Storia Ecclesiastica, 2 voli., Città Nuova, Roma, 2005.
16. Al tempo stesso W.C. van Unnik afferma che questa potrebbe essere davvero la prima attestazione a noi giunta dell'espressione «Nuovo Patto» o «Nuovo Testamento» (gr. Kaine diathèkè}.
17. È irrilevante per gli scopi del presente lavoro se questo ammonimento provenga direttamente dal veggente di Patmos o da un redattore.
18. Did. 4.13., trad. it, a cura di S. Cimes e F. Moscatelli, Didachè: dottrina dei dodici apostoli, San Paolo, Roma, 2003.
19. Giuseppe Flavio, Ap. 1.42., trad. it. a cura di F. Calabi, Contro Apione, Marietti Editore, Genova, Milano, 2007, p. 69.
20. Vd. p. 19. Un linguaggio simile riguardante l'aggiungere o il togliere ricorre nella Lettera di Aristea, 311 (vd. p. 33), dove in seguito alla traduzione in greco del Pentateuco, l'autore pronuncia una maledizione contro chi «avesse apportato revisione di qualcosa che era scritto o con aggiunte o modifiche oppure operando espunzioni»; (trad. it. a cura di P. Sacchi, Apocrifi dell'Antico Testamento, Paideia, Brescia, 1997, p. 215); due volte anche in Ireneo (haer., 4.33.8; 5.30.1. trad. it. a cura di A. Cosentino, Contro le eresie, 2 voll., Città Nuova, Roma, 2009, p. 391) - nel secondo caso contro chi riduce il numero della bestia (Ap 13:18) di 50 così da leggere 616 (forse il primo, ma non di certo l'ultimo, travisamento dell'ammonimento di Apocalisse 22:15ss. a non esercitare con leggerezza una propria critica testuale). Vd. Anche Atanasio p. 71.
INDICE
Abbreviazioni
Prefazione
Parte I Introduzione
1. Le Sacre Scritture
Parte II Antico Testamento
2.La Legge e i Profeti
3.L'Antico Testamento in greco
4.L'Antico Testamento diventa un nuovo libro
5.Il canone cristiano dell'Antico Testamento In Oriente
6.Il canone cristiano dell'Antico Testamento Nell'Occidente latino
7.Prima e dopo la Riforma
Parte III Nuovo Testamento
8.Gli scritti della nuova era
9.Marcione
10. Valentino e la sua scuola
11. La risposta cattolica
12.Il frammento muratoriano
13.Ireneo, Ippolito, Novaziano
14.Tertulliano, Cipriano e altri
15.I padri alessandrini
16.Eusebio di Cesarea
17.Atanasio e oltre
18.L'Occidente nel IV secolo fino a Girolamo
19.Da Agostino alla fine del Medioevo
20.Il canone del Nuovo Testamento nell'era della stampa
Parte IV I Conclusione
21.Criteri di canonicità
22.Un canone dentro il canone?
23.Canone, critica e interpretazione
Appendice I - Il Vangelo "segreto" di Marco
Appendice II - Il Senso primario e senso plenario
Postfazione
Indice



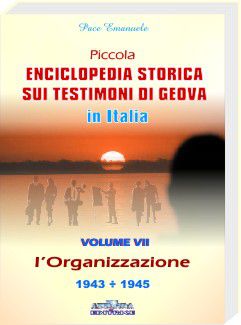 Tutta una materia, da sempre, per la quale bisogna lottare per attestarne la giusta e adeguata significazione. Lottare ieri, come oggi. E non si consideri questo mio dire un’esagerazione. La storia dei Testimoni di Geova è anche lotta contro sistemi totalitari per la libertà di culto e di religione e triste a dirsi anche contro chi il cristianesimo avrebbe dovuto professarlo.
Tutta una materia, da sempre, per la quale bisogna lottare per attestarne la giusta e adeguata significazione. Lottare ieri, come oggi. E non si consideri questo mio dire un’esagerazione. La storia dei Testimoni di Geova è anche lotta contro sistemi totalitari per la libertà di culto e di religione e triste a dirsi anche contro chi il cristianesimo avrebbe dovuto professarlo.